
Ubuntu Gnome 13.04
Finalmente dopo tante versioni di Ubuntu con Unity integrato,...

25 aprile e resistenza
Cara gentilissima signora Laura Boldrini, presidente del Senato della Repubblica italiana,

L'ancora di salvataggio
Domenica mattina 1 settembre 2013. Un uomo si affaccia da una finestra e si mette a parlare...
Il posto che spetta ad ognuno
Oggi il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo concernente l'andamento economico fino al 2050 in...
Massime del Buddha Il Pensiero
Massime del Buddha e del pensiero buddista

L'incubo continua
La legge di Murphy, quell'insieme ironico di detti popolari europei, si può sintetizzare...

Selene "Dov'eri?", videoclip
S'intitola "Dov'eri?", il secondo singolo e video della cantante Selene, ...

UE o non UE questo è il problema!
Essere o non essere. Così recitava qualche secolo fa William Shakespeare...

La nuova disperazione avanza
Ieri mattina stavo guardando in tv la diretta del giuramento dei ministri che sarebbero...

All'assalto della Costituzione
Questa notte è la notte dell'Italia. Anzi, la notte della Repubblica italiana, così come...
Platone - Protagora
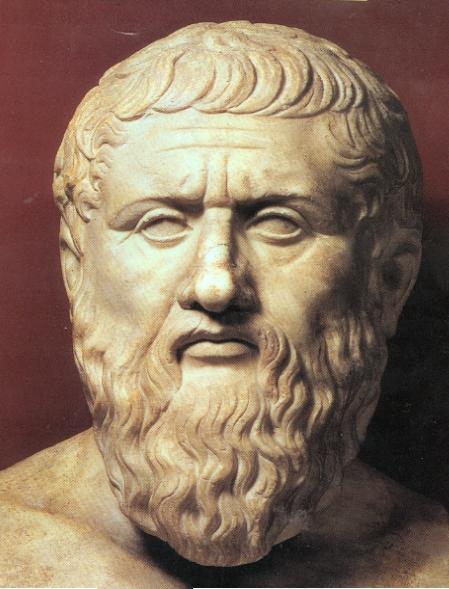
AMICO: Da dove salti fuori, o Socrate? Ma è chiaro, sicuramente torni dalla caccia al bell'Alcibiade!(1) L'ho visto ieril'altro, e mi è parso ancora un bell'uomo, e tuttavia ormai uomo, sia detto fra noi, o Socrate, che si è già quasi coperto di barba!
SOCRATE: E con questo, allora? Non sei ammiratore di Omero, il quale sosteneva che l'età più grata è quella di colui al quale spunta la prima barba,(2) appunto l'età che ha ora Alcibiade? (3)
AMICO: E ora che fai? è veramente da lui che vieni? E in che disposizione d'animo è, il giovanotto, nei tuoi riguardi?
SOCRATE: Buona, almeno mi è sembrato; anzi, oggi in modo particolare! Ha fatto molte affermazioni in mio favore, per aiutarmi, ed è proprio da lui che vengo adesso. Ma voglio confidarti una cosa ben strana: benché egli fosse lì , io non gli prestavo attenzione, e più di una volta mi dimenticai della sua presenza.
AMICO: E che potrebbe mai esser successo di tanto grave fra te e lui? Dì certo non avrai incontrato qualcun altro più bello di lui, non in questa città, almeno!(4)
SOCRATE: E molto più bello, per giunta!
AMICO: Che dici? Un cittadino o uno da fuori?
SOCRATE: Uno da fuori!
AMICO: Di dove?
SOCRATE: Di Abdera.(5)
AMICO: E un forestiero ti è sembrato essere così bello da apparire ai tuoi occhi addirittura più bello del figlio di Clinia? (6)
SOCRATE: E come potrebbe, o carissimo, non apparire più bello il più sapiente?
AMICO: Ma allora, o Socrate, è dall'incontro con un sapiente che sei di ritorno da noi?
SOCRATE: E col più sapiente dei nostri giorni, se anche tu stimi Protagora il più sapiente! (7)
AMICO: Oh! Che dici? Protagora è in città?
SOCRATE: Sono ormai tre giorni che è qui!
AMICO: Ed è proprio dall'incontro con lui che vieni?
SOCRATE: Certo! E dopo aver detto e ascoltato molte cose.
AMICO: Perché, allora, non ci racconti di quest'incontro, se non c'è nulla che te lo impedisca? Siediti qui! Fa' alzare questo schiavo!
SOCRATE: Sicuro! Anzi, vi sarò grato se mi ascolterete.
AMICO: E noi saremo grati a te, se parlerai.
SOCRATE: La gratitudine sarebbe allora reciproca. State a sentire.
La notte scorsa, quando non era ancora l'alba, Ippocrate, figlio di Apollodoro e fratello di Fasone,(8) bussò a gran forza, col bastone, alla mia porta; e, non appena qualcuno gli aprì , subito entrò, in gran fretta, e chiamando a gran voce:
«O Socrate!», disse.
«Sei sveglio o dormi?». Ed io, riconosciuta la sua voce: «Ippocrate», dissi, «sei tu? Mi porti forse qualche novità?»
«Nessuna», disse, «se non buone novità!». «Faresti bene a parlare, allora!», dissi. «Che c'è? Perché sei venuto a quest'ora?» «Protagora è qui!», disse stando in piedi accanto a me. «Già da ieri l'altro», dissi. «E tu l'hai saputo solo ora?» «Per gli dèi», disse, «l'ho saputo ieri sera!».
E intanto, cercato a tastoni il mio letto, si sedette ai miei piedi e disse: «Proprio ieri sera, sul tardi, quand'ero appena rincasato da Enoè;(9) m'era scappato uno schiavo, Satiro. Stavo proprio per venire a dirti che gli avrei dato la caccia, quando qualche altra cosa me ne fece dimenticare. Quando fui rincasato, dunque, e dopo che avevamo cenato, quando stavamo ormai per andare a dormire, proprio allora mio fratello mi disse che era arrivato Protagora. Sul momento mi accinsi a venire dritto da te, poi mi parve che fosse notte troppo inoltrata.
Ma, non appena il sonno mi lasciò libero dalla stanchezza, subito mi levai e venni qui». Ed io, conoscendo la sua indole ardente ed impulsiva, gli dissi: «E che te ne importa? Ti ha forse fatto qualche torto Protagora?». Ed egli, scoppiando a ridere, disse: «Sì , per gli dèi, o Socrate! Il torto che lui è il solo ad essere sapiente e non rende tale anche me». «Ma sì , per Zeus», dissi io, «che renderà anche te sapiente, se gli darai denaro (10) e lo convincerai!». «Per Zeus e per tutti gli dèi!», disse. «Magari dipendesse da questo! Non risparmierei un soldo né del mio denaro né dì quello degli amici! Ma è proprio per questo che ora sono venuto da te, perché tu interceda presso di lui in mio favore: io sono troppo giovane e per di più non ho mai visto Protagora, né l'ho mai sentito parlare. Ero ancora un ragazzino quando venne in città la prima volta.(11) Ma tutti, o Socrate, elogiano quest'uomo e dicono che sia grande intenditore di eloquenza.
Perché, dunque, non andiamo da lui, per poterlo trovare in casa? Egli alloggia, come ho sentito dire, in casa di Callia, figlio di Ipponico.(12) Su, andiamo!». Ed io gli dissi: «Non è ancora il momento di andare, o mio caro; è troppo presto.
Alziamoci, piuttosto, e andiamo qui, in cortile: passeremo il tempo a passeggiarvi aspettando che si faccia giorno; poi andremo. Protagora, infatti, passa la maggior parte del tempo in casa. Sicché abbi fiducia, che, com'è probabile. lo troveremo in casa».
Dopodiché, alzatici, andammo a passeggiare in cortile. Ed io, per mettere alla prova la forza d'animo di Ippocrate, lo esaminai e gli feci queste domande: «Dimmi, Ippocrate», gli chiesi: «ora tu ti appresti ad andare da Protagora a pagargli un compenso in denaro perché ti prenda sotto le sue cure; ebbene, da chi ti aspetti di andare e che cosa intendi diventare? Mettiamo, ad esempio, che tu ti fossi messo in mente di andare dal tuo omonimo Ippocrate di Cos,(13) l'Asclepiade, a dargli del denaro come compenso perché si prenda cura di te; ebbene, se qualcuno ti chiedesse: "Dimmi, Ippocrate, tu stai per pagare a Ippocrate un compenso; chi sei convinto che egli sia, per farlo?", tu, allora, che cosa gli risponderesti?» «Gli risponderei», disse, «che lo pagherei perché lo considero un medico». «E con l'intenzione di diventare che cosa?» «Di diventare medico», disse. «E supponiamo, invece, che tu ti fossi messo in mente di andare da Policleto di Argo (14) o da Fidia di Atene,(15) a pagare loro un compenso perché si prendano cura di te, e che qualcuno ti chiedesse: "Tu hai in mente di pagare questa somma di denaro a Policleto e a Fidia; ebbene, chi sei convinto che essi siano, per farlo?", che cosa risponderesti?» «Risponderei che lo farei perché li considero scultori». «E nella speranza di diventare che cosa?» «Sperando, ovviamente, di diventare scultore!». «E sia», dissi. «Ora tu ed io, giunti da Protagora, saremo disposti a pagargli un compenso in denaro perché ti prenda sotto le sue cure, spendendo tutto i nostri averi, se questi basteranno a convincerlo, altrimenti, spendendo anche quelli degli amici; ebbene, se uno, vedendoci prendere la cosa tanto seriamente, ci chiedesse: "Ditemi, o Socrate e Ippocrate, chi vi aspettate che sia Protagora per pensare di spendere da lui il vostro denaro?", noi che cosa gli risponderemmo? Quale altro nome sentiamo dire riferito a Protagora?
Ad esempio, riferito a Fidia sentiamo dire "scultore", e riferito ad Omero "poeta"; ebbene, quale nome di questo tipo sentiamo dire riferito a Protagora?» «Sofista, o Socrate! Almeno, così chiamano quest'uomo», disse. «In quanto è sofista, allora, andiamo a spendervi i nostri denai».
«Certo!». «E se qualcuno ti facesse quest'altra domanda: "E nella speranza di diventare che cosa tu vai da Protagora?"». Ed egli, arrossendo (c'era già un po' di luce, sicché lo si poteva vedere), disse: «Se questo caso somiglia ai casi precedenti, ovviamente sperando di diventare sofista».
«Ma tu, in nome degli dèi», dissi, «non proveresti vergogna a presentarti ai Greci in veste di sofista?» «Sì , per Zeus, o Socrate, se bisogna proprio ch'io dica quello che penso!». «Ma forse, o Ippocrate, tu non pensi che l'istruzione che ti verrà data da Protagora sarà qualcosa di questo tipo, ma che sarà piuttosto un'istruzione del tipo di quella che hai ricevuto dal maestro di grammatica, dal maestro di musica e dal maestro di ginnastica: tu imparasti ciascuna di queste discipline non in funzione dell'arte, per diventare cioè professionista in esse, ma solo in funzione della tua educazione spirituale, come si addice al cittadino privato e libero». «è proprio questo», disse, «il tipo di istruzione che mi aspetto di ricevere da Protagora».
«Sai, dunque, che cosa stai per fare ora, o questo ti sfugge?», continuai. «Di che cosa stai parlando?» «Parlo del fatto che tu stai per affidare la tua anima alle cure di un uomo, che, come tu dici, è un sofista. Che cosa poi sia un sofista, mi stupirei se tu lo sapessi. E se ignori questo, allora ignori pure a chi affidi la tua anima, e se questo si risolverà in un fine buono o cattivo».
«Ma io penso di saperlo», disse. «Dimmi, allora: che cosa pensi che sia un sofista?» «Penso», rispose, «che, come dice il nome stesso, egli sia l'esperto della sapienza». «Ma questo», dissi io, «lo si può dire anche dei pittori e degli architetti, vale a dire che costoro sono gli esperti della sapienza. Ma se qualcuno ci chiedesse: "Di quale tipo di sapienza sono esperti i pittori?", noi potremmo rispondergli che sono esperti di quel tipo di sapienza che mira alla realizzazione di immagini; e anche negli altri casi potremmo ripondere nello stesso modo. Se qualcuno poi ci facesse questa domanda: "Di quale tipo di sapienza è esperto il sofista?", noi che cosa potremmo rispondergli? Di produrre che cosa è egli esperto?» «Che altro potremmo dire che egli è, o Socrate, se non esperto nel rendere abili a parlare?» «Forse», dissi, «la nostra definizione potrebbe anche essere vera; tuttavia non è sufficiente. Questa risposta, infatti, chiama un'ulteriore domanda: su che cosa il sofista rende abili a parlare? Ad esempio, il maestro di cetra rende abili a parlare della stessa cosa di cui rende anche esperti, ossia dell'arte di suonare la cetra.
Non è così ?» «Sì ». «E sia. Ma il sofista, di che cosa rende abili a parlare?» «Non è evidente che egli rende abili a parlare proprio della cosa di cui rende anche esperti?» «è naturale. Ma che cos'è, allora, ciò di cui il sofista è esperto e su cui rende esperto il suo discepolo?» «Per Zeus!», disse. Non so più che cosa risponderti».
Ed io, a questo punto, gli dissi: «E allora? Sai in quale pericolo vai a mettere la tua anima? Se tu dovessi affidare a qualcuno il tuo corpo correndo il rischio che diventi buono o cattivo, faresti molte considerazioni sull'opportunità di affidarlo o no, e cercheresti consiglio dagli amici e dai parenti, riflettendovi molti giorni. Invece, quando è in gioco ciò che tu consideri più prezioso del corpo, vale a dire l'anima, dalla quale dipende la buona o cattiva riuscita di tutte le tue azioni, a seconda che essa sia, rispettivamente, buona o cattiva, in questo caso non ti sei consigliato né con tuo padre, né con tuo fratello, né con alcuno dei tuoi amici sull'opportunità di affidare o no la tua anima a questo forestiero appena arrivato da fuori; ma, saputo del suo arrivo la sera, come tu racconti, di primo mattino sei già qui, senza far parola né chiedere consiglio se tu debba o no affidarti a costui, e sei pronto a spendere il tuo denaro e quello degli amici, come se già avessi deciso che a tutti i costi bisogna frequentare la scuola di Protagora, che del resto tu non conosci, come tu stesso riconosci, e con cui non hai mai conversato; che tu chiami sofista e hai tutta l'aria di ignorare che cosa mai sia questo sofista al quale tu stai per affidare te stesso». Ed egli, dopo avermi ascoltato, disse: «Così pare, o Socrate, da quanto tu dici». «Dunque, o Ippocrate, il sofista non è forse una specie di mercante all'ingrosso (16) o rivenditore al minuto di quelle merci di cui l'anima si nutre? A me, almeno, pare che sia qualcosa del genere». «Ma di che cosa si nutre l'anima, o Socrate?» «Di conoscenze, non c'è dubbio», risposi io. E bisogna tenere gli occhi bene aperti, amico mio, che il sofista, lodando la sua mercanzia, non ci inganni, come fanno quelli che vendono il cibo del corpo, cioè il mercante e il bottegaio. Costoro, infatti, delle merci che trattano, non sanno neppur essi quale sia buona e quale sia cattiva per il corpo, ma le lodano tutte pur di venderle.
E non lo sanno neppure quelli che da loro le comprano, a meno che uno non sia maestro di ginnastica o medico. Così anche coloro che trafficano in conoscenze, portandole in giro di città in città, per smerciarle all'ingrosso o rivenderle al minuto a chi di volta in volta le desidera, lodano tutto ciò che hanno da vendere. Ma forse, o carissimo, anche fra costoro ci sono alcuni che ignorano, delle merci che trattano, quale è buona e quale è cattiva per l'anima.
E allo stesso modo lo ignorano anche quelli che da loro le comprano, a meno che uno non sia medico dell'anima. Se tu, dunque, te ne intendi di quale di queste conoscenze sia buona e quale cattiva, allora per te è un acquisto sicuro comprarle da Protagora e da chiunque altro. Altrimenti, bada, o carissimo, di non giocarti e di non mettere a repentaglio quanto hai di più caro. Infatti, c'è un pericolo ben più grande nell'acquisto di conoscenze che nell'acquisto di cibi, perché quando si comprano cibi e bevande dal bottegaio o dal mercante li si può portar via in altri recipienti, e, prima di assumerli nel proprio corpo, bevendoli o mangiandoli, dopo averli riposti in casa, si può chiedere consiglio, domandando a chi se ne intende, su quale vada mangiato o bevuto e quale no, e in che quantità e quando. Sicché nell'acquisto non c'è grande pericolo.
Conoscenze, invece, non se ne possono portar via in un altro recipiente; ma, necessariamente, una volta saldato il conto, e assunta e imparata quella conoscenza proprio nell'anima, si va via o danneggiati o beneficati. Queste faccende, dunque, esaminiamole anche con quelli più vecchi di noi, perché noi siamo ancora troppo giovani per risolvere questioni di tale importanza. Ora però, visto che ormai siamo in ballo, andiamo a sentire quest'uomo e poi, dopo che l'avremo ascoltato, ci consulteremo anche con altri.
Là, infatti, non c'è solo Protagora, ma anche Ippia di Elide, (17) e, penso, Prodico di Ceo (18) e molti altri sapienti». Presa questa decisione, ci incamminammo e, una volta giunti nel vestibolo, fermati i nostri passi, discutemmo di una questione su cui la conversazione, lungo la strada, era caduta. Dunque, per non lasciarla in sospeso ma portarla a una conclusione e solo allora entrare, poi, in casa, continuammo a discutere stando in piedi nel vestibolo, finché arrivammo ad un accordo. Ebbene, ho l'impressione che il portinaio, un eunuco, ci abbia sentiti, e può darsi che, a causa della gran folla di sofisti, fosse irritato con quelli che venivano in visita a quella casa. Certo è che, quando bussammo alla porta, dopo averci aperto e averci visti, disse: «Ahimè! Sofisti!
Non ha tempo!». E intanto, con entrambe le mani, con tutta la forza di cui era capace sbatté la porta. Noi, allora, tornammo a bussare, ed egli, senza aprire la porta, per tutta risposta ci disse: «Gente! Non avete sentito che non ha tempo?» «Ma, buon uomo», dissi io, «non è da Callia che veniamo, nè siamo sofisti. Fatti animo! Siamo venuti perché abbiamo bisogno di vedere Protagora. Annunciaci, dunque!». A quel punto, dì mala voglia, l'uomo ci aprì la porta. Una volta entrati, trovammo Protagora che passeggiava sul lato anteriore del portico. Accanto a lui passeggiavano, in ordine di posto, da una parte Callia figlio di Ipponico e il suo fratello uterino, Paralo figlio di Pericle, (19) e Carmide figlio di Glaucone; (20) dall'altra parte, l'altro figlio di Pericle, Santippo, (21) Filippide figlio di Filomelo (22) e Antimero di Mende,(23) che fra i discepoli di Protagora è quello che si fa più onore e che impara il mestiere, per diventare a sua volta sofista. Quelli, poi, che seguivano costoro da dietro per ascoltare ciò che si diceva, per la maggior parte avevano l'aria dì essere gente da fuori, di quella gente che Protagora si tira dietro da ciascuna delle città per cui passa, incantandoli con la voce come Orfeo,(24) e quelli seguono la sua voce ammaliati.
E in quel coro c'erano anche alcuni del posto. Ed io, alla vista di questo coro, fui deliziato a vedere con che cautela stavano attenti a non venire a trovarsi davanti a Protagora e a non essergli d'intralcio, e a vedere come, quando lui sì girava, e con lui si giravano quelli che camminavano al suo fianco, in bell'ordine questi uditori si dividevano facendo ala da una parte e dall'altra e, girando in circolo, tornavano a disporsi alle loro spalle in bel modo davvero.
E dopo di lui conobbi, come dice Omero,(25) Ippia di Elide, seduto su un seggio sul lato opposto del portico; intorno a lui sedevano su panche Erissimaco figlio di Acumeno,(26) Fedro del demo di Mirrinunte, (27) Androne figlio di Androzione (28) e, tra i forestieri, alcuni suoi concittadini, e altra gente ancora. Mi parve che stessero interrogando Ippia su questioni astronomiche, a proposito della natura e dei fenomeni celesti, e lui, dall'alto del suo seggio, risolveva e spiegava quanto gli veniva chiesto.
E poi vidi anche Tantalo. (29) C'era, infatti, anche Prodico di Ceo: (30) stava in una stanza che Ipponico prima usava come dispensa; ma ora, visto il gran numero di quelli che avevano preso alloggio lì , Callia aveva sgomberato anche quella e ne aveva fatto un quartiere per gli ospiti. Ebbene, Prodico era ancora a letto, avvolto in certe pelli e coperte, che erano davvero molte, a quanto sembrava.
Vicino a lui sedevano, sui letti lì accanto, Pausania del Ceramico (31) e, con Pausania, un giovane, ancora adolescente, a mio giudizio di indole buona e onesta, e senza dubbio di gran bell'aspetto.
Mi parve di sentire che il suo nome fosse Agatone, (32) e non sarei meravigliato se fosse l'amato di Pausania. C'era, dunque, questo giovanotto e i due Adimanto, il figlio di Cepide e il figlio di Leucolofide, (33) e si vedeva altra gente ancora. Di che cosa parlassero, non potevo capirlo dal di fuori, per quanto ardessi dal desiderio di sentire Prodico, perché lo considero uomo sapientissimo e divino; ma la sua voce profonda rimbombava nella stanza e rendeva incomprensibili le parole.
Eravamo appena entrati, quando dietro di noi entrarono Alcibiade il bello, (34) come tu dici, e io te ne do ragione, e Crizia figlio di Callescro.(35) Entrati che fummo, passato ancora qualche tempo a osservare quello spettacolo, ci avvicinammo a Protagora, e io dissi: «O Protagora, è per te che siamo venuti io e questo Ippocrate».
«Per parlarmi da solo», disse, «o anche davanti agli altri?» «Per noi», risposi, «non fa alcuna differenza; piuttosto, quando avrai udito il motivo per cui siamo giunti, sarai tu a decidere». «Qual è, dunque», disse, «il motivo per cui siete giunti?» «Questo Ippocrate è uno di qui, figlio di Apollodoro, di famiglia importante e ricca, e lui stesso per natura, mi sembra, può competere coi suoi coetanei. Ha l'ambizione, mi pare, di diventare persona di spicco in questa città, ed è convinto che questo gli riuscirebbe con particolare successo se solo potesse frequentarti.
Ora vedi tu, se pensi che di queste cose si debba discutere da solo a solo, o in presenza di altri». «è giusto, o Socrate», disse, «che tu ti prenda di questi riguardi nel mio interesse. Per un forestiero, infatti, che va nelle grandi città e in esse convince il fiore della gioventù a lasciare la compagnia degli altri, sia dei familiari sia degli estranei, sia dei più vecchi sia dei più giovani, e a frequentare lui nella speranza di diventare migliori per effetto della sua compagnia; ebbene, per chi fa questo è necessario esser molto cauti, perché non piccole invidie nascono intorno a queste cose, per non dire di altri rancori e insidie.
Io affermo che la sofistica è un'arte antica, ma che quegli antichi che la praticavano, nel timore dell'odiosità che essa suscita, si sono costruiti un paravento e ce l'hanno nascosta dietro, alcuni il paravento della poesia, come Omero,(36) Esiodo (37) e Simonide; (38) altri quello dei riti e dei vaticini, come Orfeo, (39) Museo (40) e i loro adepti; mi sono accorto poi di alcuni che perfino della ginnastica si sono fatti paravento, come Icco di Taranto (41) e colui che è tuttora sofista a nessuno inferiore, Erodico di Selimbria, nativo di Megara.(42) Si servì , invece, della musica come paravento il vostro Agatocle,(43) che fu grande sofista, e come lui Pitoclide di Ceo (44) e molti altri. Tutti costoro, come dicevo, per paura dell'invidia si servirono di queste arti come coperture. Io, invece, dissento in questo da tutti costoro: non credo, infatti, che abbiano ottenuto ciò che speravano. In effetti, agli uomini che hanno potere nelle città non passano inosservati gli scopi che questi paraventi hanno.
Certo, la maggior parte della gente non si accorge, diciamo, di niente, ma ripete come un ritornello le dichiarazioni di costoro. Ora, se uno, mentre tenta di sfuggire, non la fa franca, ma la sua fuga viene scoperta, è gran follia anche il solo averla tentata, e, di necessità, questo rende gli uomini molto più ostili, perché pensano che una persona del genere sia, oltre al resto, anche un truffatore. Io, quindi, ho imboccato la strada opposta alla loro: ammetto di essere un sofista e di educare gli uomini, e ritengo che questo, cioè ammetterlo anziché negarlo, sia una cautela più efficace dell'altra. E oltre a questa ho escogitato altre precauzioni, in modo che, con l'aiuto di un dio, non mi capiti alcun guaio per il fatto di ammettere che sono un sofista. Eppure, sono anni ormai che pratico quest'arte, e certo, mettendo insieme i miei anni, molti ne ho: non c'è nessuno fra tutti voi di cui io, per età, non possa essere padre. Sicché, se avete qualche richiesta, preferisco di gran lunga che ne parliate di fronte a tutti i presenti».
Ed io, sospettando che egli volesse farsi bello di fronte a Prodico e a Ippia e pavoneggiarsi del fatto che noi eravamo arrivati lì perché suoi ammiratori, dissi: «Perché, allora, non chiamiamo anche Prodico e Ippia e quelli che sono con loro, affinché possano stare ad ascoltare?» «Sicuro!», disse Protagora.
«Volete, allora», chiese Callia, «che faccia preparare una sala coi seggi, perché possiate discutere stando seduti?». Parve che così si dovesse fare, e noi tutti, contenti al pensiero che avremmo ascoltato quei sapienti, presi da noi gli scanni e le panche, li sistemammo vicino ad Ippia, perché lì c'erano già altri scanni. In quella giunsero Callia e Alcibiade, portandosi dietro Prodico, che avevano fatto alzare dal letto, e quelli che si trovavano insieme a Prodico.
Come ci fummo tutti seduti, Protagora disse: «Ora che anche costoro sono presenti, o Socrate, dimmi pure ciò a cui prima accennavi a proposito di questo giovanotto».
Ed io dissi: «Il motivo principale che ci ha spinti qui, o Protagora, è lo stesso di cui poco fa ti dicevo. Questo Ippocrate desidera frequentare la tua compagnia. Che cosa gliene verrà, frequentandoti, sarebbe contento, lui dice, di saperlo. Questo è quanto avevamo da dirti».
Protagora, allora, prese la parola e disse: «Giovanotto, se mi frequenterai, sin dal giorno medesimo che comincerai a frequentarmi, potrai tornartene a casa migliore di prima, e il giorno successivo la stessa cosa. E di giorno in giorno farai continui progressi verso il meglio».
Ed io, udito ciò, dissi: «O Protagora, questo che dici non è nulla di stupefacente, ma è normale, dal momento che anche tu, benché così avanti negli anni e così sapiente, se qualcuno ti insegnasse qualcosa che tu avessi la ventura di ignorare, diventeresti migliore. Ma la questione non va posta in questi termini: piuttosto, supponiamo che Ippocrate, mutando improvvisamente desiderio, volesse frequentare quel giovane che è da poco in città, Zeusippo di Eraclea, (45) e che, andato da lui, come ora è venuto da te, si sentisse dare da lui la stessa risposta che ora sente da te, e cioè che ogni giorno, a frequentare lui, diventerebbe migliore e farebbe progressi.
Ora, se gli facesse quest'altra domanda: "In che cosa mi assicuri che sarò migliore e farò progressi?", Zeusippo gli risponderebbe che questo accadrebbe nella pittura. E supponiamo che, andato a trovare Ortagora di Tebe, (46) dopo aver sentito da lui le stesse cose che ora ha sentito da te, gli chiedesse in che cosa diventerebbe di giorno in giorno migliore frequentandolo, quello gli risponderebbe che diventerebbe migliore nell'arte di suonare il flauto. Ebbene, è in questi termini che anche tu devi rispondere a questo giovane e a me che ti interrogo per suo conto: "Questo nostro Ippocrate, frequentando Protagora, fin dal giorno stesso in cui prenderà a frequentarlo se ne andrà migliore di come è venuto, e così continuerà a fare progressi per ciascuno dei giorni successivi: ma progressi verso che cosa, o Protagora, e in quale campo?"».
E Protagora, udite queste mie domande, rispose: «Le tue domande sono a proposito, o Socrate, ed io rispondo volentieri a chi fa domande appropriate. Se Ippocrate verrà da me, non gli capiterà quello che gli accadrebbe frequentando un altro sofista, perché gli altri sofisti rovinano i giovani; infatti, mentre costoro sono fuggiti dalle arti, quelli tornano a gettarli nelle arti, trascinandoveli contro voglia, insegnando loro calcolo, astronomia, geometria e musica», e intanto gettò un'occhiata verso Ippia. «Frequentando me, invece, non imparerà altro se non ciò per cui è venuto. E il mio insegnamento ha come oggetto il buon senso, (47) sia nelle faccende private, ossia come amministrare al meglio la propria casa, sia negli affari della città, ossia come diventare abilissimo nel curare gli interessi della città, nell'agire e nel parlare».
«Dimmi», dissi allora, «se riesco a seguire il tuo ragionamento: mi pare che tu stia parlando dell'arte politica e che prometta di fare degli uomini dei buoni cittadini».
«E' proprio questa, o Socrate», rispose, «la professione che io professo!».
«Bell'acquisto davvero», dissi, «quest'arte che possiedi, ammesso che tu la possieda! Non ti dirò altro se non quello che penso. Non credevo, Protagora, che questo si potesse insegnare, ma, visto che tu lo sostieni, non ho motivo di non crederti. è giusto, però, che io spieghi l'origine della mia convinzione che questo non si potesse insegnare né procurare da uomo a uomo. Io sostengo, come del resto anche gli altri Elleni sostengono, che gli Ateniesi sono molto sapienti.
Ebbene, io vedo che, quando ci raduniamo in assemblea, se la città ha a che fare con questioni che riguardano la costruzione di edifici, si fanno intervenire in veste di consiglieri in materia di costruzioni gli architetti; se, invece, deve prendere qualche decisione circa la costruzione di navi, si mandano a chiamare i costruttori di navi, ed è lo stesso il criterio seguito quando si tratta di tutte le altre cose che, essi ritengono, si possano imparare ed insegnare. Ma se prova a dar loro consigli qualcun altro che essi non stimano pratico dì quel dato mestiere, per quanto sia bello, ricco e nobile, non per questo lo ascoltano, ma lo deridono ed esprimono il proprio malcontento levando un gran baccano, finché colui che ha tentato di parlare, interrotto da quel baccano, non desista per conto suo, o gli arcieri non lo tirino via e lo caccino fuori per ordine dei Pritani. (48) Così agiscono, dunque, in quelle questioni che essi ritengono dipendere da un'arte.
Quando invece si tratta di decidere circa l'amministrazione della città, allora si leva a dar loro consigli su tali questioni, indifferentemente, l'architetto, il fabbro, il calzolaio, il mercante, l'armatore, il ricco, il povero, il nobile e il plebeo, e a costoro nessuno rinfaccia, come invece si rinfaccia a quelli del caso precedente, di mettersi a dar consigli senza aver prima imparato da qualche parte e senza aver avuto alcun maestro. è chiaro che questo accade perché non la considerano cosa che si possa insegnare. E bada che questo non accade solo nella vita pubblica della città, ma che anche nella vita privata i più sapienti e i migliori cittadini non sono capaci di trasmettere ad altri quella virtù che essi possiedono.
Pericle, ad esempio, padre di questi giovani, (49) diede loro un'educazione ineccepibile in quelle cose che dipendono dai maestri, mentre in quelle cose in cui è egli stesso sapiente, né li educa personalmente, né li affida ad altri, ma lascia che pascolino circolando liberamente come animali sacri, affinché possano, in qualche posto, imbattersi da soli nella virtù. E se vuoi un altro caso, lo stesso Pericle, avendo la tutela di Clinia, (50) fratello minore del nostro Alcibiade, e nutrendo per lui il timore che venisse corrotto da Alcibiade, lo staccò da costui e lo mise in casa di Arifrone,(51) perché lo educasse; ebbene, prima che fossero passati sei mesi, quello glielo restituì , non sapendo farne nulla di buono. E potrei farti il nome di moltissimi altri uomini, che, per quanto buoni fossero essi stessi, non riuscirono mai a rendere migliore nessun altro, né dei familiari né degli estranei. Se io, dunque, guardo a questi casi, o Protagora, non penso che la virtù sia insegnabile. Ma adesso che ti sento fare queste affermazioni, mi lascio piegare e penso che quello che dici deve pur valere qualcosa, perché credo che tu abbia esperienza di molte cose, che molte le abbia imparate e molte le abbia scoperte per conto tuo. Perciò, se hai modo di mostrarci con maggiore evidenza che la virtù è insegnabile, non rifiutarci questa dimostrazione».
«Ma io, o Socrate», disse, «non mi rifiuterò! Preferite, invece, che io, come anziano che si rivolge a gente giovane, ve lo dimostri raccontando un mito o analizzandolo col ragionamento?».
Molti dei presenti gli risposero che lo dimostrasse pure come voleva.
«Allora», diss'egli, «a me pare che sarebbe più gradito se io vi raccontassi un mito.
C'era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non esistevano le stirpi mortali. Quando poi anche per queste venne il tempo destinato per la loro creazione, furono dèi a foggiarle, nell'interno della terra, mescolando terra e fuoco e quelle sostanze che si fondono con fuoco e terra. E quando era destino che dovessero portarle alla luce, assegnarono a Prometeo e ad Epimeteo (52) l'incarico di fornire e di distribuire facoltà a ciascuna razza come si conviene. Ma Epimeteo chiese a Prometeo di lasciar fare a lui la distribuzione: "Quando le avrò distribuite", gli disse, "tu verrai a controllare". E, dopo averlo così persuaso, mise mano alla distribuzione.
Nel corso della distribuzione, ad alcune razze assegnò la forza senza la velocità, mentre fornì le razze più deboli di velocità. Certe razze le provvide di armi di difesa, per altre, invece, cui aveva conferito una natura inerme, escogitò qualche altra facoltà che assicurasse loro la salvezza. Infatti, quelle razze che rivestì di piccolezza, le provvide della capacità di fuggire con le ali, o di rifugiarsi in tane sotterranee; a quelle che invece fece crescere in grandezza, garantì la salvezza proprio con questo mezzo. E le altre facoltà le distribuì cercando di compensarle in questo modo. Ed escogitò questo avendo la cautela che nessuna specie potesse estinguersi. Dopo che le ebbe provviste di vie di scampo dalla distruzione reciproca, escogitò un efficace espediente perché si proteggessero contro le stagioni mandate da Zeus, vestendole di peli folti e di pelli spesse, adatte a proteggerle dal freddo e capaci di difenderle anche dalla calura, e tali che, quando si mettono a dormire, ciascuna specie trovi in esse le sue coltri personali e naturali. E alcune le calzò di zoccoli, altre invece le provvide di pelli spesse e senza sangue. In seguito, procacciò certi cibi per certe specie, altri per altre: ad alcune specie riservò le erbe della terra, ad altre i frutti degli alberi, ad altre le radici.
E vi sono specie cui concesse di trovare il loro nutrimento predando altre specie animali. E fece in modo che le une fossero poco feconde, e che quelle destinate a esser preda di queste fossero invece molto prolifiche, al fine di assicurare la conservazione della specie. Se non che, non essendo un tipo molto accorto, Epimeteo non s'avvide di aver speso tutte le facoltà con gli animali: gli restava ancora sprovvista la razza umana, e non sapeva trovare una soluzione. Mentre si trovava impacciato in quest'inghippo, Prometeo viene a controllare il risultato della distribuzione, e vede che le altre specie animali erano ben provviste di tutto, mentre l'uomo era nudo, scalzo, scoperto e inerme. Ed era ormai vicino il giorno predestinato in cui bisognava che anche l'uomo uscisse dalla terra alla luce. Prometeo, allora, trovandosi in difficoltà circa il mezzo di conservazione che potesse trovare per l'uomo, ruba ad Efesto e ad Atena la loro sapienza tecnica insieme al fuoco, perché senza il fuoco era impossibile acquisirla o utilizzarla, e così ne fa dono all'uomo. Grazie ad essa l'uomo possedeva la sapienza necessaria a sopravvivere, ma gli mancava ancora la sapienza politica, perché questa era in mano a Zeus. Prometeo poi non aveva più accesso all'acropoli, dimora di Zeus; per di più, c'erano anche le terribili guardie di Zeus. Egli allora s'introduce furtivamente nell'officina che Atena ed Efesto avevano in comune, in cui essi lavoravano insieme, e, rubata l'arte del fuoco di Efesto e quell'altra arte che apparteneva ad Atena, la dona all'uomo: di qui vennero all'uomo i mezzi per vivere. Ma in seguito, come si racconta, Prometeo, per colpa di Epimeteo, venne punito per quel furto.
E, poiché l'uomo venne ad aver parte di un destino divino, innanzi tutto, per via di questa sua parentela col dio, solo fra gli animali credette negli dèi, e si mise a innalzare altari e statue di dèi. In seguito, con l'arte presto articolò voce e parole, inventò dimore, vesti, calzari, giacigli e scoprì i cibi che venivano dalla terra.
Così provvisti, all'inizio gli uomini abitavano in insediamenti sparsi, e non esistevano città. Perciò morivano uccisi dalle fiere, poiché erano sotto ogni rispetto più deboli di esse, e l'arte artigiana che essi possedevano bastava loro a procurarsi cibo, ma non era sufficiente alla guerra contro le fiere. Infatti, non possedevano ancora l'arte politica, di cui l'arte della guerra è parte. Cercavano quindi di unirsi e di salvarsi fondando città. Ma, una volta che si erano uniti, si facevano torti l'un l'altro, perché non possedevano l'arte politica, sicché, tornando a disperdersi, morivano. Zeus, allora, temendo che la nostra specie si estinguesse, manda Ermes a portare agli uomini rispetto e giustizia, perché fossero regole ordinatrici di città e legami che uniscono in amicizia. Ermes chiede a Zeus in quale modo dovesse dare agli uomini giustizia e rispetto: "Devo distribuirli seguendo lo stesso criterio con cui si sono distribuite le arti? Perché quelle vennero distribuite in questo modo: uno solo che possieda l'arte medica basta per molti che di quell'arte sono profani, e così per gli altri specialisti.
Ebbene, giustizia e rispetto devo distribuirli fra gli uomini con questo criterio, o devo distribuirne a tutti?" "A tutti", disse Zeus, "che tutti ne diventino partecipi. Perché non potrebbero nascere città, se solo pochi di loro ne avessero parte, come accade per le altre arti. Istituisci, anzi, una legge per conto mio: chi è incapace di partecipare di rispetto e giustizia sia messo a morte come flagello della città". Così stanno le cose, Socrate, e queste sono le ragioni per cui gli Ateniesi, e gli altri, quando si tratta della competenza nell'arte di costruire o di qualunque altra competenza artigiana, credono che solo a pochi spetti il diritto di partecipare alle decisioni, e se uno, che sia al di fuori di quei pochi, si mette a dare consigli, non lo tollerano, come tu dici: e con ragione, dico io. Quando invece si riuniscono in assemblea su questioni che hanno a che fare con la virtù politica, questioni che vanno trattate interamente con giustizia e temperanza, allora, giustamente, lasciano che chiunque dia il proprio parere, nella convinzione, appunto, che a tutti spetti di partecipare di questa virtù, o non esisterebbero città. Questa, Socrate, ne è la ragione.
Ma perché tu non creda di essere ingannato circa la mia affermazione che tutti ritengono che ogni uomo partecipi della giustizia e di ogni altra virtù politica, eccotene la prova. In tutte le altre competenze, come dici, se qualcuno afferma di essere, ad esempio, un abile suonatore di flauto, o di essere abile in qualsiasi altra arte in cui invece non lo sia, o ridono di lui o gli si adirano contro, ed i suoi di casa vanno da lui e cercano di farlo tornare in sé dandogli del pazzo. Quando si tratta invece di giustizia o di qualsiasi altra virtù politica, anche se tutti sanno che uno è ingiusto, quando costui dica contro il proprio interesse la verità di fronte a molta gente, la stessa cosa che nel caso precedente veniva considerata saggezza, cioè il dire la verità, in questo caso viene considerata segno di pazzia; e sostengono che tutti devono dichiarare di essere giusti, che lo siano o no, e che è pazzo chi non finge di esserlo. E questo accade perché sono convinti che ognuno debba necessariamente, in un modo o nell'altro, partecipare di questa virtù, o che, nel caso contrario, non debba vivere fra gli uomini.
Il concetto che ti ho ora espresso7 dunque, è che gli Ateniesi accettano con ragione che ogni uomo dia consigli quando si tratta di virtù politica, per il fatto che sono convinti che ognuno partecipa di essa. E il prossimo concetto che tenterò di dimostrarti è che questa virtù non è un dono di natura né del caso, ma che è insegnabile e che chi la possiede la raggiunge grazie all'impegno. Nel caso di quei mali, infatti, che gli uomini credono, gli uni degli altri, di avere per natura o per caso, nessuno si sdegna, né ammonisce o ammaestra o rimprovera quelli che li hanno, perché smettano di essere tali, ma ne provano pietà. Chi potrebbe, ad esempio, essere così insensato da mettersi a fare una cosa del genere coi brutti, coi piccoli o coi deboli? Tutti sanno infatti, ne sono convinto, che queste cose vengono agli uomini perché portate dalla natura o dal caso, ossia le belle qualità e i difetti corrispondenti.
Nel caso, invece, di quelle qualità che si considerano essere per gli uomini frutto di impegno, di esercizio e di insegnamento, quando uno non le abbia, ed abbia invece i difetti opposti a quelle qualità, su costui e su quelli come lui cadono collere, rimproveri e ammonimenti. E uno di questi mali è l'ingiustizia, l'empietà, e, in somma, tutto ciò che è contrario alla virtù politica. è per questo che tutti si sdegnano contro tutti e a tutti dispensano le proprie esortazioni, evidentemente perché sono persuasi che la virtù politica è frutto di impegno e di studio. Se tu, o Socrate, vorrai considerare quale effetto può avere il punire coloro che commettono ingiustizia, questo basterà ad insegnarti che gli uomini considerano la virtù cosa che possa essere trasmessa. Nessuno, infatti, punisce i colpevoli di ingiustizie in considerazione del fatto che commisero ingiustizia e per questo motivo, a meno che uno, come una belva, non cerchi irrazionale vendetta. Ma chi tenta di punire razionalmente, non punisce per l'ingiustizia passata, perché non potrebbe far sì che ciò che è stato fatto non sia accaduto, ma punisce pensando al futuro, perché non torni a compiere ingiustizie né quello stesso individuo né altri che lo veda punito.
E chi ha una tale opinione, pensa che la virtù possa essere oggetto di educazione: è per prevenzione, dunque, che punisce. E quest'opinione è condivisa da tutti coloro che puniscono, e nella vita privata e in quella pubblica. E così gli altri popoli puniscono e castigano coloro che essi ritengono colpevoli di ingiustizia, e non meno degli altri gli Ateniesi tuoi concittadini. Sicché, secondo questo ragionamento, anche gli Ateniesi rientrano fra quelli che credono che la virtù possa essere trasmessa ed insegnata.
Che, dunque, a ragione i tuoi concittadini ammettano anche un fabbro o un calzolaio a dar consigli negli affari politici, e che ritengano che la virtù si possa insegnare e trasmettere, o Socrate, ti è stato dimostrato a sufficienza, almeno a mio giudizio.
Resta quindi ancora una difficoltà che tu non sapevi risolvere a proposito degli uomini valenti: perché mai quegli uomini che sono valenti insegnano ai propri figli quelle altre cose che dipendono dai maestri e in queste cose li rendono sapienti, mentre in quella virtù in cui essi stessi sono valenti non sono capaci di renderli migliori di nessun altro. Su questo punto, Socrate, non ti racconterò più un mito, ma ti farò un ragionamento. Prova a considerare la questione in questo modo: esiste o non esiste una cosa unica, di cui è necessario che tutti i cittadini partecipino, perché possa esserci una città? Qui sta infatti la soluzione della difficoltà che tu poni e da nessun'altra parte. Se dunque questa cosa esiste, e se questa cosa unica non è né l'arte del costruttore né quella del fabbro né quella del vasaio, ma è la giustizia, la temperanza e la santità, e quella che, per chiamarla con un nome solo, io chiamo virtù dell'uomo; ebbene, se è questa la cosa di cui tutti gli uomini devono partecipare e con cui ogni uomo deve imparare e fare ogni altra cosa che voglia imparare o fare, e senza la quale non deve fare nulla; se chi non ne partecipa va istruito e punito, si tratti di fanciullo, uomo o donna, finché non diventi migliore attraverso la punizione; se chi non si sottomette alle punizioni e agli insegnamenti, va considerato inguaribile e cacciato dalla città o ucciso; se, dunque, le cose stanno così , e se, pur essendo questa la sua natura, gli uomini valenti insegnassero ai propri figli tutte le altre cose tranne questa, considera quanto sarebbero strani questi valentuomini!
Ora, che essi la considerino cosa che possa essere insegnata, e nella vita privata e in quella pubblica, lo abbiamo già dimostrato. Ed essi, mentre essa è insegnabile e coltivabile, insegnano ai figli le altre cose, per le quali, nel caso le ignorassero, non esiste la pena di morte, e quella cosa invece per la quale, nel caso non l'imparassero e non la coltivassero fino a diventarne valenti, li attende la pena di morte e l'esilio, e, oltre alla morte, la confisca dei beni e, in una parola, la rovina della casa; ebbene, proprio questa cosa non l'insegnano e non se ne curano con tutto l'impegno? Bisogna proprio crederlo, Socrate! Cominciando fin dalla più tenera infanzia dei figli fino a che vivano, continuano a dar loro insegnamenti e ammonimenti. E, non appena uno comincia ad intendere il senso di quanto gli vien detto, la nutrice, la madre, il precettore e il padre stesso si danno un gran da fare perché il bambino diventi quanto possibile migliore, ad ogni sua azione o parola insegnandogli e mostrandogli: "Questo è giusto e questo ingiusto; questo è bello e questo brutto; questo è santo e questo empio; queste cose falle e queste altre non farle". E questo se egli obbedisce di sua spontanea volontà. Altrimenti, come si fa con un legno storto e piegato, lo raddrizzano a colpi di minacce e botte. Più tardi, poi, quando lo mandano alla scuola dei maestri, raccomandano loro di curare molto di più la buona condotta dei ragazzi che non l'insegnamento delle lettere e dell'arte di suonar la cetra. I maestri, dunque, li prendono sotto le proprie cure, e, quando sanno ormai leggere e possono capire il senso degli scritti come prima capivano il senso di quanto veniva detto, danno loro da leggere, sui banchi, opere di validi poeti, e li costringono a imparare a memoria quelle opere in cui abbondano ammonimenti, narrazioni, elogi ed encomi di virtuosi uomini del passato, perché il ragazzo, mosso da spirito di emulazione, li imiti e desideri diventare tale e quale. I maestri di cetra, a loro volta, fanno la stessa cosa: si prendono cura della loro temperanza, e badano che i giovani non facciano nulla di male. Poi, una volta che abbiano imparato a suonare la cetra, insegnano loro le opere di altri validi poeti lirici, facendole eseguire coll'accompagnamento della cetra, e fan sì che i ritmi e le armonie diventino familiari alle anime dei fanciulli, perché siano più mansueti, e, trovato maggior equilibrio e maggiore armonia, siano capaci di parlare e di agire in modo benefico. Tutta la vita dell'uomo, infatti, richiede equilibrio ed armonia. Ed ancora, oltre a ciò, li mandano anche dal maestro di ginnastica, affinché abbiano corpi migliori da mettere al servizio di una mente sana, e perché il cattivo stato del corpo non li metta nella condizione di cedere alla paura in guerra e in altre imprese. E queste cose le fanno coloro che hanno maggiori possibilità, e ad avere maggiori possibilità sono i più ricchi: i loro figli, mentre cominciano a frequentare le scuole dei maestri in età più giovane rispetto agli altri, più tardi degli altri le lasciano.
E quando hanno lasciato la scuola, la città a sua volta li costringe ad imparare le leggi ed a vivere tenendole come modello, affinché non possano agire a proprio arbitrio ed a caso. E, in tutto e per tutto come fanno i maestri di grammatica con quei fanciulli che non sono ancora capaci di scrivere, che, solo dopo aver abbozzato con lo stilo le tracce delle lettere, danno loro la tavoletta e li fanno scrivere seguendo le linee tracciate, così anche la città, dopo aver segnato il tracciato delle leggi, scoperte da antichi e valenti legislatori, costringe a governare e ad obbedire conformandosi a quelle, e punisce chi si muova al di fuori di esse. E a questa punizione, qui da voi come in molti altri luoghi, si dà il nome di "raddrizzare", significando con questo che la pena raddrizza.
Ora, benché vi sia tutta questa cura della virtù in privato e in pubblico, tu ti stupisci, o Socrate, e non sai capire se la virtù sia insegnabile? Ma non bisogna stupirsene, e anzi bisognerebbe stupirsi molto di più se essa non fosse insegnabile!
Ma perché, allora, da padri valenti nascono figli buoni a nulla? Eccotene la ragione: non c'è nulla di sorprendente in questo, se nelle mie precedenti affermazioni dicevo il vero, quando cioè sostenevo che di questa cosa, ossia della virtù, nessuno deve esserne all'oscuro, perché una città possa esistere. Ebbene, se quello che dico è vero, e lo è al di sopra di ogni altra cosa, scegli una qualsiasi altra occupazione o scienza e rifletti. Se ad esempio non fosse possibile che una città esistesse, a meno che non fossimo tutti suonatori di flauto, ognuno come ne fosse capace, e a meno che tutti non insegnassero a tutti quest'arte, e in privato e in pubblico, e non coprissero di biasimo chi non suonasse bene, e se non si tenesse gelosamente per sé la conoscenza di quest'arte, come ora nessuno tiene gelosamente per sé la conoscenza del diritto e delle leggi, né la tiene nascosta, come si fa invece con la conoscenza delle altre arti (e questo avviene, io credo, perché la giustizia reciproca e la virtù è per noi un guadagno: è per questo che tutti sono pronti a dire e ad insegnare a tutti ciò che è giusto e conforme alla legge); se, dunque, questa fosse la situazione e noi avessimo tutto questo zelo e tutta questa generosità nell'insegnarci l'un l'altro l'arte di suonare il flauto, pensi forse, o Socrate, che i figli di flautisti eccellenti avrebbero maggiori probabilità di diventare a loro volta eccellenti flautisti rispetto ai figli di flautisti mediocri?
Io credo di no! Credo invece che diventerebbe famoso chi nascesse con le più favorevoli disposizioni naturali all'arte di suonare il flauto, di chiunque egli fosse figlio, e che, d'altra parte, resterebbe senza gloria chi nascesse senza naturali disposizioni per quell'arte, di chiunque egli fosse figlio. E spesso, anzi, da un grande flautista può nascerne uno mediocre, e, al contrario, da un flautista mediocre può nascerne uno eccellente. Tutti, però, sarebbero flautisti abbastanza abili, se paragonati a coloro che di quest'arte sono profani e che non s'intendono per nulla di flauto. E così anche in questo caso, credilo pure, quell'uomo che ti sembra essere un campione di ingiustizia fra quanti sono stati allevati nelle leggi e nel consorzio umano, costui ti darebbe l'impressione di essere uomo giusto e anzi maestro in questo campo, se ti trovassi a giudicarlo in confronto a uomini che non avessero avuto né un'educazione spirituale, né tribunali, né leggi, né alcuna forma di costrizione che li obbligasse, in ogni circostanza, a tener conto della virtù, ma fossero selvaggi del tipo di quelli che l'anno scorso il poeta Ferecrate (53) portò in scena nel Leneo. (54) Certo, se tu ti trovassi fra uomini del genere, come i misantropi in quel coro, saresti ben contento di poter incontrare Euribate e Frinonda, (55) e ti lagneresti rimpiangendo la malvagità degli uomini di qui. Ora invece, Socrate, fai il delicato, perché tutti sono maestri di virtù, nella misura in cui ciascuno ne è capace, e quindi nessuno ti sembra essere tale. E come se tu, per fare un esempio, cercassi chi è maestro del parlar greco: non ce ne sarebbe uno che ti parrebbe tale! Né, credo, ci sarebbe qualcuno che ti parrebbe tale, se tu cercassi chi ha insegnato ai figli dei nostri artigiani quell'arte, appunto, che essi hanno imparato dal padre, nella misura in cui il padre e gli amici del padre che facevano lo stesso mestiere ne erano capaci. Ebbene, chi altri abbia insegnato loro l'arte e risulti quindi loro maestro, non credo sia facile stabilirlo, o Socrate, mentre è senz'altro facile stabilire chi sia stato il maestro di chi era del tutto all'oscuro di una data arte. E così accade nel caso della virtù e di tutte le altre cose. Se poi c'è qualcuno che ci superi anche di poco nella capacità di farci strada verso la virtù, c'è di che esserne contenti. E io penso di essere precisamente uno di questi, e di poter essere utile, più di ogni altro uomo, a far diventare altri gente per bene, e di farlo in un modo che vale ben il compenso che io esigo, e anche di più, tanto che lo stesso discepolo è di quest'opinione. Per questo ho dato disposizioni che la riscossione del mio compenso avvenga nel seguente modo: una volta che uno ha imparato da me, se vuole, mi paga il prezzo che io stabilisco altrimenti, entrato in un tempio, dichiara sotto giuramento quanto, a suo giudizio, valgono gli insegnamenti ricevuti, e quel tanto poi mi paga.
E con questo, Socrate, ti ho narrato un mito ed esposto un ragionamento che ti dimostrano come la virtù si possa insegnare e come gli Ateniesi siano di quest'opinione, e che non è cosa di cui stupirsi che da padri eccellenti nascano figli buoni a nulla, e da padri mediocri figli eccellenti: anche i figli di Policleto, (56) coetanei di Paralo e Santippo (57) qui presenti, non sono niente, se paragonati al padre, e così accade per i figli di altri artefici.
Ma su costoro non è ancora il caso di emettere questa sentenza: in loro, infatti, vi sono ancora speranze, poiché sono giovani».
Dopo essersi esibito in tante e tali dimostrazioni, Protagora smise di parlare. Ed io, per molto tempo ancora, rimasi incantato a guardarlo, nella speranza che dicesse ancora qualcosa, tanto grande era il mio desiderio di starlo a sentire. Ma quando mi resi conto che aveva veramente smesso, allora, con l'aria di essermi a stento riavuto, dissi, rivolgendomi a Ippocrate «Figlio di Apollodoro, quanto ti sono grato per avermi spinto a venire qui! Considero infatti cosa di grande valore l'avere udito ciò che ho appena udito da Protagora. In passato non ritenevo che i buoni fossero tali in virtù di un'umana cura; ora, invece, ne sono persuaso.
Se non fosse per un dettaglio che mi mette in difficoltà, che, com'è chiaro, Protagora saprà risolvere facilmente, visto che ha saputo spiegare a fondo tutto il resto. Se uno, infatti, s'intrattenesse su tali argomenti con uno qualsiasi degli oratori politici, probabilmente sentirebbe fare discorsi di questo tipo anche da Pericle o da chiunque altro abbia il dono dell'eloquenza. Ma se poi si facesse a qualcuno di loro qualche altra domanda, essi, come libri scritti, (58) non avrebbero nulla da rispondere, né da chiedere a loro volta. E se uno tornasse a chiedere chiarimenti anche su un particolare di ciò che da loro è stato detto, allora, come fanno i vasi di bronzo, che, percossi, continuano per lungo tempo a risuonare finché qualcuno non li prenda in mano, così anche i retori, interrogati circa piccole questioni, tirerebbero avanti un discorso lungo un dolico. Il nostro Protagora, invece, è capace di fare lunghi e bei discorsi, come mostrano questi che ha appena fatto, ma è anche capace, quando lo si interroghi, di rispondere brevemente, e, quand'è lui a interrogare, di aspettare e di ricevere la risposta: cosa, questa, che a pochi riesce. Ebbene, ora, Protagora, mi manca un particolare per avere un quadro completo, cioè che tu risponda a questa mia domanda. Tu sostieni che la virtù è insegnabile, e se c'è uno fra gli uomini a cui posso credere, quello sei tu. C'è una cosa, però, che mi sono meravigliato di sentirti dire, ed è questo il bisogno che devi appagare nella mia anima. A tuo dire, Zeus avrebbe mandato agli uomini la giustizia e il rispetto, e, del resto, più volte nel corso del tuo ragionamento hai parlato di giustizia, di temperanza, di santità e di tutte queste cose come se nell'insieme fossero una cosa sola, vale a dire la virtù. Ed è proprio questo quello che vorrei tu mi spiegassi in modo preciso, col ragionamento, cioè se la virtù è una cosa sola e la giustizia, la temperanza e la santità sono parti di essa, oppure se questi che io ora ho menzionato sono tutti nomi del medesimo ed unico essere. Questo è ciò che ancora mi preme capire».
«è facile, o Socrate», disse, «rispondere a questa domanda: essendo la virtù un'unica cosa, quelle di cui tu mi domandi sono parti di essa».
«E in che modo», gli chiesi, «sono parti di essa? Nel modo in cui bocca, naso, occhi e orecchi sono parti del volto, o nel modo in cui le parti dell'oro non differiscono in nulla le une dalle altre, fra di loro e in rapporto al tutto, se non in grandezza o in piccolezza?» «Io direi nel primo modo, Socrate, ossia nel modo in cui le parti del volto stanno in rapporto all'intero volto». «E gli uomini», dissi, «partecipano chi di una chi di un'altra di queste parti della virtù, o è necessario che, quando se ne abbia acquistata una, le si possieda, per questo, tutte?» «Non è affatto necessario», rispose, «visto che molti sono coraggiosi ma ingiusti; oppure sono giusti ma non saggi». «Anche queste, dunque», dissi, «sono parti della virtù, ossia la sapienza e il coraggio?» «Al di sopra di tutto», rispose. «Anzi, la sapienza ne è la parte più importante». «E ciascuna di esse», dissi, «è diversa dalle altre parti?» «Sì ». «E ciascuna di esse ha una sua particolare funzione? Per esempio, nel caso delle parti del volto, l'occhio non è come l'orecchio, né la sua funzione è la stessa, e nessuna delle altre parti è uguale all'altra, né nella funzione che le è propria né nel resto. Forse è così anche per le parti della virtù, che l'una non è uguale all'altra, né in se stessa né nella funzione che le è propria? Non è forse evidente che le cose stanno così , se il caso in questione somiglia all'esempio?» «Ma le cose stanno proprio così , Socrate!», rispose.
Allora dissi: «Dunque nessun'altra parte della virtù è come la conoscenza, né come la giustizia, né come il coraggio, né come la temperanza, né come la santità». «Non lo è», disse. «Su, allora», dissi, «esaminiamo insieme quale sia la natura di ciascuna di esse. Prima di tutto, esaminiamo questo: la giustizia è una cosa reale o non lo è? A me, infatti, pare che lo sia. E a te, che te ne pare?» «Anche a me pare che lo sia», disse. «E allora, se qualcuno chiedesse a me e a te: "O Protagora e Socrate, ditemi: questa cosa che avete appena nominato, ossia la giustizia, è essa stessa giusta o ingiusta?", io gli risponderei che è giusta. E tu che voto daresti? Il mio stesso voto, o un voto diverso?» «Il tuo stesso voto», rispose.
«La giustizia, dunque, si identifica con l'essere cosa giusta, direi io in risposta a chi me lo chiedesse. Diresti così anche tu?» «Sì », disse. «E se allora, dopo questa, ci facesse quest'altra domanda: "Non dite che esiste anche una certa cosa detta santità?"; noi risponderemmo che esiste, almeno credo». «Sì », disse. «"E non dite che anche questa è una cosa reale?"; noi risponderemmo che lo è. O no?». Anche su questo si disse d'accordo. «"E dite che questa stessa cosa si identifica con l'essere, per natura, cosa empia o cosa santa?". Io a questa domanda andrei in collera», dissi, «e risponderei: "Bada a come parli, o uomo! A stento, infatti, potrebbe esserci qualcos'altro di santo, se la santità stessa non fosse santa". Ma tu che ne dici? Non risponderesti anche tu così ?» «Certamente», disse.
«Se poi costui ci chiedesse: "Come dicevate poco fa? Forse allora non vi ho capito bene! Mi è parso che voi sostenevate che le parti della virtù stanno, le une rispetto alle altre, in un rapporto tale che l'una non è come l'altra"; io gli risponderei: "Il resto l'hai capito bene; quanto al fatto invece che anch'io avrei affermato questo, hai frainteso: è stato infatti il nostro Protagora a dare questa risposta, mentre io glielo stavo solo domandando". Se quindi domandasse: "Dice la verità costui, o Protagora? Sei tu a sostenere che le parti della virtù sono una diversa dall'altra? E tua questa affermazione?", tu che cosa gli risponderesti?» «Dovrei necessariamente ammetterlo, o Socrate», disse.
«Ebbene, Protagora, fatta questa ammissione, che cosa gli risponderemmo, se ci chiedesse: "La santità, allora, non è tale da esser cosa santa, e la giustizia non è tale da esser cosa santa, ma è tale, invece, da esser cosa non santa? E la santità è tale da esser cosa non giusta, ma ingiusta, e l'altra, vale a dire la giustizia, tale da esser cosa empia?". Che cosa gli risponderemmo? Io, per me almeno, gli risponderei che sia la giustizia è cosa santa, sia la santità è cosa giusta. E anche per te, se tu mi lasciassi fare, darei questa stessa risposta, vale a dire che la giustizia si identifica con la santità, o che almeno le è molto simile, e che la giustizia è uguale alla santità e la santità alla giustizia più di quanto non lo siano fra loro tutte le altre parti. Vedi, dunque, se non mi lasci dare questa risposta, o se anche tu sei di quest'opinione». «Non mi pare affatto, Socrate», disse, «che la questione sia così semplice da riconoscere che la giustizia è cosa santa e la santità cosa giusta; piuttosto, mi pare che vi sia una certa differenza. Ma che importa?», proseguì . «Se vuoi, ammettiamo pure che la giustizia sia cosa santa e la santità cosa giusta». «Non mi va bene!», dissi. «Non ho alcun bisogno che questo "se vuoi" e quel "se ti pare" sia oggetto di confutazione, ma che nella confutazione ci si riferisca a "me e te".
E questo "me e te" lo dico nella convinzione che il miglior modo di sottoporre il ragionamento a confutazione è quello di togliere via quel "se"». «Ma del resto», disse, «la giustizia ha qualche somiglianza con la santità: qualsiasi cosa assomiglia, per un verso o per l'altro, a qualsiasi cosa! Il bianco, infatti, in un certo senso, assomiglia al nero, il duro al molle, e così le altre cose che pure sembrano all'apparenza le più contrarie fra loro. Anche quelle cose che prima dicevamo avere una diversa funzione ed essere l'una diversa dall'altra, ossia le parti del volto, per un certo verso si assomigliano e sono l'una uguale all'altra. Sicché, in questo modo almeno, se tu volessi, potresti dimostrare anche l'ipotesi contraria, cioè che tutte le cose sono simili fra loro. Ma non è giusto chiamare simili le cose che hanno qualcosa in comune, come non lo è chiamare dissimili le cose che hanno qualcosa di dissimile, se quello che hanno in comune è ben poca cosa». Ed io, stupito, gli dissi: «Per te, allora, il giusto e il santo stanno fra loro in termini tali da avere in comune ben poca cosa?» «Non è precisamente così », rispose, «ma nemmeno come tu mi sembri pensare che sia!».
«Allora», dissi, «visto che mi sembri avere una certa avversione per quest'argomento, lasciamolo perdere ed esaminiamo quest'altra tua affermazione. C'è qualcosa che tu chiami stoltezza?». Disse di sì . «E la saggezza non è l'esatto contrario di questa cosa?» «Mi pare di sì », disse. «E quando gli uomini compiono azioni corrette e utili, ti pare che siano temperanti ad agire così , o ti pare il contrario?» «Che siano temperanti», disse. «E non sono forse temperanti in virtù della temperanza?» «Necessariamente».
«E quelli che compiono azioni non corrette, non si comportano forse stoltamente? E non è forse vero che non sonotemperanti se così si comportano?» «Pare anche a me», disse. «Il comportarsi stoltamente non è allora il contrario del comportarsi in modo temperato?».
Disse che lo era. «E le azioni compiute stoltamente non sono forse compiute per effetto di stoltezza, mentre quelle compiute in modo temperato lo sono per effetto di temperanza?» Lo ammise. «E se un'azione è compiuta con forza, non è forse compiuta fortemente, mentre se è compiuta con debolezza è compiuta debolmente?» Gli parve che fosse così . «E se è compiuta con velocità, velocemente, e se è compiuta con lentezza, lentamente?». Disse di sì . «E quando un'azione è compiuta in un certo modo, è compiuta per effetto di quella certa cosa, e se è compiuta in modo contrario, per effetto della cosa contraria?».
Si disse d'accordo. «Su, allora», dissi, «c'è qualcosa che sia il bello?».
Lo ammise. «E c'è qualcosa che sia a questo opposto e che non sia il brutto?» «Non c'è». «Ed esiste il bene?» «Esiste». «Ed esiste qualcosa che sia a questo opposto e che non sia il male?» «Non esiste». «Ed esiste una qualità nella voce che sia l'acuto?».
Disse di sì . «Ed esiste una qualità che sia a questa opposta e che non sia il grave?». Disse di no. «Allora», dissi io, «per ciascuna cosa esiste un solo contrario e non molti». Riconobbe che era così .
«Su allora», dissi, «riepiloghiamo quanto abbiamo insieme convenuto. Abbiamo convenuto che per ogni singola cosa esiste un solo contrario e non più di uno?» «Lo abbiamo convenuto». «E che l'azione compiuta in un dato modo contrario è compiuta per effetto di quella data cosa contraria?». Disse di sì . «Abbiamo convenuto che l'azione compiuta stoltamente è compiuta in modo contrario all'azione compiuta in maniera temperata?».
Disse di sì . «E che l'azione compiuta in modo temperato è compiuta per effetto di temperanza, mentre quella compiuta stoltamente è compiuta per effetto di stoltezza?» «Sì ». «E se quest'azione è compiuta in modo contrario a quella, non dovrebbe allora esser compiuta per effetto di una cosa contraria?» «Sì ». «E l'una è compiuta per effetto di stoltezza, mentre l'altra lo è per effetto di temperanza?» «Sì ». «In modo contrario?» «Certo». «Dunque, per effetto di cose contrarie?» «Sì ». «La stoltezza non è allora il contrario della temperanza?» «Così pare!». «Ti ricordi, dunque, che nel precedente ragionamento abbiamo convenuto che la stoltezza è contraria alla saggezza?» Lo ammise. «E che per ogni singola cosa esiste un solo contrario?» «Sì ». «Allora, Protagora, quale di queste due affermazioni dobbiamo lasciar cadere: l'affermazione che per ogni singola cosa esiste un solo contrario, o quella con cui si sosteneva che la saggezza è diversa dalla temperanza, e che l'una e l'altra sono parti della virtù, e che, oltre a essere diverse, sono anche dissimili, e in se stesse e nelle loro funzioni, come accade per le parti del volto? Quale delle due affermazioni lasciar cadere? A sostenerle entrambe, infatti, queste due affermazioni non sono fra loro in sintonia, perché non si accordano né si armonizzano fra loro. Come potrebbero, del resto, accordarsi se, per necessità, per ogni singola cosa esiste un solo contrario, e non più di uno, mentre alla stoltezza, che è una cosa sola, appaiono contrarie saggezza e temperanza? E così , Protagora, o le cose stanno in qualche altro modo?». Lo ammise anche se piuttosto malvolentieri. «Non dovrebbero allora essere una cosa sola la saggezza e la temperanza? Del resto, prima ci è parso che la giustizia e la santità fossero quasi la stessa cosa! Su, Protagora», continuai, «non facciamoci prendere dalla stanchezza ed esaminiamo anche il resto.
Un uomo che commetta ingiustizia, ti pare che agisca con temperanza nel commettere ingiustizia?» «Mi vergognerei, o Socrate», rispose, «ad ammettere questo, benché molti uomini lo sostengano». «A costoro, dunque, dovrò rivolgere il mio ragionamento», dissi, «o a te?» «Se vuoi», rispose, «discuti prima contro quest'affermazione, che rappresenta l'opinione della maggior parte della gente». «Ma per me non fa alcuna differenza se questa sia o non sia la tua opinione, purché tu mi risponda, almeno. Infatti, è l'opinione in se cio che innanzi tutto esamino, anche se forse poi accade che ad essere esaminati siamo tanto io che interrogo quanto colui che risponde». Sulle prime Protagora fece il ritroso con noi, e adduceva la scusa che l'argomento era scabroso; ma poi accettò di rispondere.
«Su», dissi, «rispondimi da capo: esistono uomini che ti sembrano agire con temperanza pur commettendo ingiustizia?» «E sia», rispose. «Ma tu dici che essere temperante equivalga ad essere assennato?». Disse di sì . «E dici che l'essere assennato consiste nel prendere la giusta decisione, quando si commette ingiustizia?» «E sia», disse. «E in quale dei due casi?», dissi io. «Quando, commettendo ingiustizia, si riesce bene, o quando si falliscono i propri intenti?» «Quando si riesce bene». «E ci sono cose che definisci buone?» «Ce ne sono». «E sono buone», dissi, «le cose che sono utili agli uomini?» «Sì , per Zeus!», rispose. «E ci sono cose che io chiamo buone anche se non sono utili agli uomini».
Avevo l'impressione che Protagora fosse ormai irritato, agitato e in allarme nel dare le sue risposte. Poiché lo vedevo in questo stato, con molta cautela delicatamente gli chiesi: «Stai parlando, Protagora, di cose che non sono utili agli uomini, o di cose che non sono utili in generale? Anche cose di questo genere tu le definisci buone?» «Niente affatto», rispose. «Ma conosco molte cose che per gli uomini sono nocive, cibi, bevande, farmaci e infinite altre cose; altre che invece sono utili; altre che per gli uomini non sono né nocive né utili, ma lo sono per i cavalli; altre poi che lo sono solo per le vacche, altre per i cani; altre ancora che non lo sono per nessuna specie animale, ma per le piante. E, fra queste, alcune fanno bene alle radici della pianta, ma sono dannose ai germogli: per fare un esempio, il letame è buono se viene gettato alle radici di tutte le piante, ma, se si volesse spargerlo sui rami giovani e sui germogli, manderebbe tutto in rovina. E anche l'olio è dannosissimo per tutte le piante e grande nemico dei peli di tutte le bestie, eccetto i peli dell'uomo; per i peli dell'uomo, come per il resto del corpo, è invece benefico. Il bene è una cosa tanto varia e multiforme che, anche nel caso dell'olio, una data cosa è buona, per l'uomo, per le parti esterne del corpo, e quella stessa cosa è invece dannosissima per le parti interne. Perciò tutti i medici proibiscono ai malati di far uso di olio, se non in minima quantità mescolato alle cose che il malato deve mangiare, quel tanto che basta a cancellare la sensazione di nausea che essi provano all'odore dei cibi e delle vivande».
Quand'ebbe detto ciò, i presenti applaudirono fragorosamente, significando, con questo, che a loro giudizio aveva parlato bene.
Allora dissi: «Protagora, si dà il caso che io sia uomo di poca memoria, e se uno mi fa lunghi discorsi, dimentico l'argomento di cui si parlava. Ebbene, se mi accadesse di essere un po' sordo, penseresti, trovandoti a dover discutere con me, che con me bisogna parlare a voce più alta che con gli altri. Così anche ora, visto che ti sei imbattuto in uno che ha poca memoria, per me tieni pure corte le tue risposte e falle più brevi, se vuoi che ti segua».
«E come pretendi che io ti dia brevi risposte? Devo forse risponderti più in breve del dovuto?», disse.
«Niente affatto», risposi io.
«Devo allora darti risposte lunghe quanto occorre?», chiese.
«Sì », risposi.
«Ma dovrò darti risposte lunghe quanto sembra a me che debbano esserlo, o quanto sembra a te?» «Ho sentito dire», dissi allora, «che tu, sugli stessi argomenti, sei capace, sia tu per tuo conto sia di insegnare ad altri a farlo, di tenere, quando vuoi, lunghi discorsi, in modo tale che la parola non ti viene mai a mancare, e che d'altra parte sai anche tenere discorsi tanto brevi, che nessuno potrebbe parlarne più in breve di te.
Se, quindi, vuoi discutere con me, serviti di questo secondo modo nel rivolgerti a me, ossia del parlare in modo conciso».
«Socrate», rispose, «sono ormai molti gli uomini con cui sono arrivato a contesa verbale, e se avessi fatto allora quello che tu ora pretendi che io faccia, vale a dire se avessi discusso nella maniera in cui l'avversario pretendeva che io discutessi, non avrei avuto la meglio su nessuno, né si farebbe il nome di Protagora fra i Greci».
Ed io, sapendo che non era soddisfatto delle risposte che mi aveva dato prima e che non avrebbe acconsentito di buon grado a dialogare nella parte di chi risponde, pensai che non potevo più cavarne nulla a restare in quella compagnia e dissi: «Protagora, neppure io muoio dalla voglia che questa nostra conversazione si svolga in modo contrario al tuo parere, ma quando tu vorrai discutere in modo che io possa seguirti, allora io discuterò con te.
Tu, infatti, a quel che si dice di te, e come tu stesso sostieni, sai reggere il dialogo sia coi lunghi discorsi che coi discorsi concisi, perché sei sapiente. Io, invece, sono incapace di questi lunghi discorsi, per quanto vorrei esserne capace. Bisognerebbe che fossi tu ad adattarti a me, visto che sei capace di entrambi, perché la nostra discussione potesse aver luogo. Ma ora, visto che non sei disposto a farlo e io ho un impegno e non posso star qui con te che tiri i tuoi discorsi per le lunghe, perché bisogna che io vada in un posto, vado, anche se forse non senza piacere starei a sentirti».
E nel dire ciò, mi alzai e feci per andarmene. Ma, mentre mi alzavo, Callia mi afferrò per la mano con la destra, e con la sinistra mi prese per questo mantello, e disse: «Non lasceremo che tu te ne vada, Socrate, perché se tu te ne vai, la nostra discussione non sarà più la stessa. Ti chiedo dunque di restare fra noi: non c'è nulla che starei a sentire con un piacere maggiore di quanto ne provo a sentir discutere te e Protagora. Fa' un favore a tutti noi!».
Ed io dissi, quando ormai mi ero già alzato con l'intenzione di uscire: «O figlio di Ipponico, da sempre ammiro il tuo amore per la sapienza, ma ora lo lodo e lo apprezzo in modo particolare, al punto che davvero vorrei farti questo favore, se solo tu mi chiedessi cosa che potessi fare. Ma ora è come se tu mi chiedessi di tenere il passo col corridore Crisone d'Imera (59) quand'è al meglio della sua forma, o di gareggiare nella corsa e tener dietro a uno di quei corridori di lunghe distanze (60) o a uno di quei corrieri che corrono un giorno intero: (61) io ti risponderei che sono io a domandare a me stesso, molto più di quanto tu non faccia, di tener dietro alla loro corsa, ma non ne sono capace, e se la tua richiesta è proprio quella di vedere me e Crisone correre insieme, chiedi a lui di rallentare, perché io non so correre veloce, mentre egli sa correre lentamente. Se, dunque, desideri ascoltare me e Protagora, pregalo che, come prima dava risposte brevi e pertinenti alle domande che gli venivano rivolte, così anche ora risponda.
Altrimenti, che genere di metodo avranno mai i nostri dialoghi?
Io, infatti, ho sempre considerato cose diverse il trovarsi insieme a discutere e il tenere discorsi in piazza». «Ma vedi, Socrate», disse Callia, «a me pare che Protagora dica cose giuste, reclamando il suo diritto di discutere nel modo in cui vuole lui, e, d'altro canto, il tuo diritto di discutere come vuoi tu».
Allora Alcibiade, (62) presa la parola, disse: «Non dici bene, o Callia.
Il nostro Socrate, infatti, ammette che non è da lui parlare in modo prolisso e si arrende a Protagora. Quanto, però, al saper sostenere una discussione, e al sapersi destreggiare nel dare e ricevere risposte, mi stupirei se fosse secondo a qualcuno. Se, dunque, anche Protagora ammette di essere inferiore a Socrate nel sostenere una discussione, Socrate è soddisfatto. Se invece s'impunta a far valere i suoi diritti, allora accetti di discutere facendo domande e dando risposte, senza sviluppare un lungo discorso ad ogni domanda, eludendo le obiezioni e rifiutandosi di giustificare le proprie affermazioni, ma tirando la cosa per le lunghe finché la maggior parte degli ascoltatori non abbia dimenticato qual era l'oggetto della domanda. Quanto a Socrate, infatti, vi garantisco io che non se ne dimenticherebbe, e che scherza, quando dice di aver poca memoria. A me pare, quindi, che le pretese di Socrate siano, più ragionevoli, dato che ciascuno deve esprimere la propria opinione».
Dopo Alcibiade, mi pare fu Crizia (63) a parlare: «O Prodico e Ippia, mi sembra che Callia sia in tutto e per tutto dalla parte di Protagora; Alcibiade, poi, è il solito attaccabrighe in ogni cosa in cui si mette. Ma noi non dobbiamo schierarci né dalla parte di Socrate né dalla parte di Protagora, bensì stare uniti a pregare l'uno e l'altro di non disfare nel bel mezzo la riunione».
Com'egli ebbe detto ciò, Prodico (64) disse: «Mi pare che tu dica bene, o Crizia bisogna, infatti, che coloro che sono presenti a questo genere di discussioni, siano uditori imparziali di entrambi coloro che discutono, ma non equanimi.
Non è la stessa cosa, infatti: bisogna stare a sentire entrambi in modo imparziale, ma non dare uguale importanza all'uno e all'altro, bensì darne di più al più sapiente e meno al meno sapiente. Io, per conto mio, o Protagora e Socrate, vi domando di mettervi d'accordo e di sostenere, sì , tesi opposte sugli argomenti in discussione, ma di non entrare in contesa. Anche fra amici, infatti, ci si contraddice l'un l'altro per benevolenza, mentre a contendere fra loro sono gli avversari e i nemici. E in questo modo la nostra discussione sarebbe bellissima: voi che discutete, così facendo, avreste in sommo grado la stima di noi ascoltatori, senza venire lodati; la stima, infatti, ha sede nell'anima degli ascoltatori senza inganno, mentre la lode si trova spesso nelle parole di gente che mente contro quello che pensa. Quanto a noi ascoltatori, poi, se le cose avvenissero in questo modo, proveremmo il massimo della gioia, senza provare piacere: si prova gioia, infatti, quando s'impara qualcosa e si attinge al sapere proprio con la mente, mentre si prova piacere quando si mangia o quando si sperimenta qualche altra sensazione piacevole proprio con il corpo».
Come Prodico ebbe detto ciò, molti dei presenti espressero la loro approvazione. Dopo Prodico fu Ippia il sapiente (65) a parlare, e disse: «Uomini qui presenti, io considero voi tutti consanguinei, imparentati e concittadini per natura, non per legge: il simile è infatti per natura imparentato al simile, mentre la legge, che è tiranna degli uomini, forza contro la natura molte cose.
è quindi vergognoso che noi, mentre conosciamo la natura delle cose, e siamo i più sapienti dei Greci e proprio per questo siamo oggi convenuti in quello che è il pritaneo (66) della sapienza della Grecia, e nella casa più illustre e più ricca di questa città, diamo tuttavia a vedere di non essere per niente degni di questo nostro prestigio, ma ci comportiamo fra di noi come i più volgari degli uomini.
Io vi prego e vi esorto, dunque, o Protagora e Socrate, a venirvi incontro metà strada dando retta a noi che facciamo da arbitri conciliatori tu, Socrate, non impuntarti a ottenere a tutti i costi quella concisa forma di dialogo che si svolge per brevi battute, se questa non piace a Protagora, ma dà corda e allenta le redini ai discorsi, perché ci appaiano più solenni e più eleganti; e tu, Protagora, a tua volta, spiegando tutte le vele, abbandonandoti al vento favorevole, non fuggire nel mare aperto dei discorsi, perdendo di vista la terra; piuttosto, tenete entrambi una via di mezzo. Così dovete fare, datemi retta e sceglietevi un arbitro, un sovrintendente e un presidente, che sorvegli per voi la giusta lunghezza dei discorsi di ciascuno».
Queste parole piacquero ai presenti e tutti le elogiarono. Quanto a me, Callia disse che non mi avrebbe lasciato andar via e mi fu chiesto di scegliere un sovrintendente. Io, allora, dissi che sarebbe stato offensivo scegliere qualcuno che facesse da arbitro ai nostri discorsi: «Se il prescelto sarà inferiore a noi, non sarà giusto che l'inferiore presieda ai migliori; se sarà nostro pari, nemmeno così andrà bene, perché uno che sia nostro pari farà anche cose uguali a noi, sicché sceglierlo sarà inutile. Ma allora dovrete scegliere uno migliore di noi! In verità, secondo me, sarà impossibile per voi scegliere qualcuno che sia più sapiente del nostro Protagora.
Se poi ne sceglierete uno per niente migliore, e sosterrete tuttavia che lo è, anche questo sarà offensivo nei suoi confronti, il scegliere cioè per lui un sovrintendente, come se lui fosse uomo da poco. Quanto a me, poi, non me ne importa nulla. Sono però disposto a fare così , perché la nostra riunione e i nostri discorsi possano avere lo sviluppo che voi desiderate: se Protagora non vuole rispondere, faccia pure lui le domande ed io risponderò, e nello stesso tempo tenterò di mostrargli come io sostengo debba rispondere colui che risponde. Quando, però, io avrò risposto a tutto quello che lui vorrà domandarmi, prometta, a sua volta, di rispondermi allo stesso modo. E se non sembrerà disposto a rispondere proprio alla domanda che gli vien fatta, allora io e voi, insieme, lo pregheremo delle stesse cose di cui ora voi pregate me, vale a dire di non rovinare la riunione. E non ci sarà alcun bisogno, per fare questo, che qualcuno sia nominato sovrintendente, ma sarete voi, tutti insieme, a fare da arbitri». A tutti parve che così si dovesse fare. Quanto a Protagora, la cosa non gli andava proprio a genio, ma fu tuttavia costretto ad acconsentire a fare lui le domande, e, quando ne avesse fatte abbastanza, a giustificare a sua volta le proprie affermazioni rispondendo con brevi risposte. Iniziò, dunque, a interrogare press'a poco così : «Socrate, credo», disse, «che la parte più importante dell'educazione spirituale di un uomo consista nell'essere esperto di poesie; e questo a sua volta consiste nel saper capire, fra quanto i poeti hanno detto, quali opere siano state ben composte e quali no, nel saper fare distinzioni e, se interrogato, nel saperle spiegare. Ebbene, la mia domanda, ora, riguarderà sempre lo stesso argomento su cui io e tu stiamo discutendo, vale a dire la virtù, anche se riferita alla poesia.
Ad un certo punto, Simonide, (67) rivolgendosi a Scopa, figlio di Creonte il Tessalo, (68) dice: "Diventare uomo buono veramente è difficile, di mani, di piede, di cuore tetragono, senza pecca costruito". Conosci questo carme, (69) o devo recitartelo per intero?».
Allora risposi: «Non ce n'è alcun bisogno: conosco il carme, e anzi si dà il caso che mi sia interessato molto ad esso».
«Dici bene», disse; «e ti pare che sia stato composto in modo bello e giusto?» «Bello e giusto davvero!», risposi. «E penseresti che è stato composto in bel modo, se il poeta contraddicesse se stesso?» «Se così fosse, penserei che non è stato composto in bel modo», dissi io.
«E allora», disse, «guarda meglio!». «Ma, amico mio, l'ho esaminato abbastanza!». «Allora tu sai», disse, «che, andando avanti col carme, egli dice: "Né appropriato mi suona il detto di Pittaco, (70) benché proferito da uomo sapiente: difficile, diceva, essere buono. Ti accorgi che è la stessa persona a fare queste affermazioni e quelle di prima?» «Lo so», risposi. «Ebbene», disse, «ti sembra che queste concordino con quelle?» «A me pare di sì », risposi.
Ma intanto cominciavo a temere che in quello che diceva ci fosse qualcosa di vero. «Perché, a te pare di no?», soggiunsi. «E come potrebbe sembrare coerente con se stesso chi sostiene entrambe queste affermazioni? Prima pone la premessa che è difficile diventare veramente uomo buono; poi, poco avanti nel carme, se ne dimentica e rimprovera Pittaco che dice le stesse cose che diceva lui, e cioè che è difficile essere buono, e dice di non approvarlo, benché costui faccia le sue stesse affermazioni! Ebbene, visto che rimprovera chi fa le sue stesse affermazioni, è chiaro che rimprovera anche se stesso, sicché, o non è corretta la prima cosa che ha detto o non è corretta la seconda».
E con queste parole scatenò l'applauso e la lode di molti degli ascoltatori. Quanto a me, in un primo momento, come se fossi stato colpito da un buon pugile, mi si oscurò la vista e fui preso da vertigini a queste sue parole e al frastuono degli applausi.
Poi, a dirti la verità allo scopo di guadagnar tempo per riflettere su che cosa volesse dire il poeta, mi rivolsi verso Prodico, e, chiamatolo, gli dissi: «O Prodico, Simonide è dopo tutto tuo concittadino: è giusto, quindi, che sia tu a venire in suo aiuto.
Mi pare, dunque, di poterti chiamare in soccorso, come Omero narra che lo Scamandro, cinto d'assedio da Achille, chiamasse in aiuto il Simoenta, dicendo: caro fratello, cerchiamo insieme di trattenere la forza di quest'eroe.(71) Così anch'io ti chiamo in soccorso, perché Protagora non ci espugni Simonide. Per restaurare Simonide, infatti, c'è proprio bisogno della tua arte, con cui distingui volere e desiderare dimostrando che non sono la stessa cosa, e con cui fai quelle numerose e belle distinzioni di cui poco fa dicevi. E ora guarda se anche tu la pensi come me, perché a me non pare che Simonide contraddica se stesso. Tocca a te, Prodico, esprimere la tua opinione: ti sembra che "diventare" ed "essere" siano la stessa cosa, o cose diverse?» «Per Zeus, diverse!», rispose Prodico. «Ebbene», dissi, «nei primi versi Simonide non ha forse espresso la propria opinione, sostenendo che diventare uomo buono è davvero difficile?» «Dici il vero», disse Prodico.
«E rimprovera, invece, Pittaco», dissi, «non, come pensa Protagora, perché dice le stesse cose che dice lui, ma perché dice una cosa diversa. Non era questo, infatti, che Pittaco definiva difficile, ossia diventare buono, come invece sosteneva Simonide, bensì esserlo.
Essere e divenire, Protagora, non sono la stessa cosa, come attesta il nostro Prodico. E se essere non ha lo stesso significato di divenire, allora Simonide non si contraddice. E forse il nostro Prodico, e con lui molti altri, direbbero, con le parole di Esiodo, che diventare buono è difficile perché davanti alla virtù gli dèi hanno posto sudore, ma che, giunto che uno sia in cima ad essa, torna poi facile, per quanto ardua essa sia, conservarne il possesso». (72) Prodico, udito ciò, si congratulò con me. Protagora invece disse: «La tua restaurazione, o Socrate, implica un errore più grande di quello che intendevi risanare».
Ed io risposi: «A quanto pare, allora, ho fatto un cattivo lavoro, Protagora, e sono un medico ridicolo: curandolo, rendo il male più grave».
«è proprio così », disse.
«E come?», gli chiesi.
«Ben grande», disse, «sarebbe l'ignoranza del poeta, se sostenesse che è cosa da poco conservare il possesso della virtù, quand'essa è, di tutte le cose, la più difficile, come tutti pensano».
Ed io dissi: «Per Zeus! Prodico capita davvero a proposito nei nostri discorsi! Si dà il caso, infatti, Protagora, che quella di Prodico sia un'antica sapienza di origine divina, sia che abbia preso inizio da Simonide, sia ancora più anticamente. E tu, pur essendo al corrente di molte altre cose, è evidente che di questa sei all'oscuro, a differenza di me, che ne sono invece esperto, per essere stato discepolo del nostro Prodico. E così , ora mi sembri non capire che, forse, Simonide non dava alla parola "difficile" il significato che le dai tu. Lo stesso vale per la parola "terribile": ogni volta che io, con l'intenzione di lodare te o qualcun altro, dico che Protagora è uomo sapiente e terribile, Prodico mi rimprovera e mi chiede se io non provi vergogna a chiamare terribili le cose buone; ciò che è terribile, lui dice, è cattivo. Nessuno, perciò, dice, di volta in volta, "terribile ricchezza", né "terribile pace", né "terribile salute", ma "terribile malattia", "terribile guerra" e "terribile povertà", nella convinzione che ciò che è terribile sia cattivo.
Ebbene, forse anche alla parola "difficile" quelli di Ceo e Simonide attribuiscono il significato di "cattivo", o qualche altro significato che tu non conosci. Chiediamolo dunque a Prodico, perché è giusto interrogare lui sulla lingua di Simonide! Che voleva dire Simonide con la parola "difficile", Prodico?» «Cattivo», rispose.
«E per questo, allora», dissi io, «o Prodico, che rimprovera a Pittaco l'affermazione che "è difficile essere buono": è come se l'avesse sentito dire che è cosa cattiva essere buono!».
«Ma, Socrate», disse, «cos'altro credi che Simonide abbia detto se non questo, e cos'altro credi che rimproveri a Pittaco, se non la sua incapacità di distinguere correttamente le parole, da cittadino di Lesbo qual era, e perciò allevato in una lingua barbara?» «Ebbene», dissi, «o Protagora, senti anche tu il nostro Prodico.
Hai qualcosa da obiettare a queste sue affermazioni?» E Protagora: «Ce ne vuole», disse, «a che le cose stiano così , o Prodico! So bene, invece, che anche Simonide usava la parola "difficile" nello stesso significato in cui la usiamo noi altri, vale a dire non nel senso di "cosa cattiva", ma nel senso di "cosa che non è facile, e che si ottiene a prezzo di molte fatiche"».
«Ma anch'io penso», dissi, «o Protagora, che Simonide intendesse dire questo, e che anche il nostro Prodico losappia, ma che stia scherzando e voglia metterti alla prova, per vedere se sarai capace di sostenere il tuo ragionamento.
Del fatto, poi, che Simonide, con "difficile", non intendesse dire "cattivo", ne è prova evidente il verso a questo successivo: un dio solamente potrebbe avere questo privilegio. Se egli intendesse dire questo, e cioè che è un male essere buono, di certo poi non verrebbe a dire che solo il dio ha questa prerogativa e non attribuirebbe solo al dio questo privilegio: se così fosse, Prodico direbbe che Simonide è un insolente e per nulla un cittadino di Ceo. Ma voglio dirti qual è la mia interpretazione del pensiero di Simonide in questo carme, se vuoi mettere alla prova la mia competenza in fatto di poesia, come tu la chiami. Ma, se vuoi, sarò io ad ascoltare te».
Protagora allora, uditomi dire ciò, disse: «Se vuoi, Socrate!». Prodico e Ippia, invece, mi pregarono con insistenza, e così gli altri.
«Allora», dissi, «cercherò di esporvi la mia interpretazione di questo carme. L'amore per la sapienza è antichissimo e fra i Greci fu coltivato, più che altrove, a Creta e a Sparta, e là i sapienti sono più numerosi che in qualsiasi altro posto della terra.
Ma essi lo negano e fingono di essere ignoranti, perché non si scopra che sono superiori fra gli Elleni grazie alla sapienza, come quei sofisti di cui parlava Protagora, e per dare a credere, invece, di essere superiori in guerra e in coraggio, credendo che, se si venisse a conoscere la cosa che li rende superiori, ossia la sapienza, tutti si metterebbero a coltivarla. Ora, invece, tenendo questa ben nascosta, hanno ingannato quelli che nelle altre città si atteggiano a Spartani e che, per imitarli, si spaccano le orecchie e si fanno intorno ai pugni cinghie di cuoio, sono fanatici di ginnastica e indossano mantelli corti, convinti che siano queste le fonti della superiorità degli Spartani sul resto dei Greci. Ma gli Spartani, quando hanno voglia di frequentare liberamente i loro sofisti e sono ormai stanchi di farlo di nascosto, bandiscono dalla città questi stranieri che si atteggiano a Spartani e qualunque altro straniero che soggiorni nella loro città, e s'incontrano coi sofisti all'insaputa degli stranieri, e non permettono che nessuno dei loro giovani esca per recarsi in altre città, cosa che neppure i Cretesi permettono, perché non disimparino quello che essi insegnano loro. E in questa città non solo gli uomini sono orgogliosi della loro educazione spirituale, ma anche le donne. E potreste avere la conferma che queste cose sono vere e che gli Spartani hanno avuto la migliore educazione all'amore per la sapienza e all'arte dei discorsi, facendo questa considerazione: se uno volesse intrattenersi a discutere col più inetto degli Spartani, troverà che costui nella maggior parte dei ragionamenti apparirebbe uno sciocco, ma poi, dove questo cade a proposito nel corso del ragionamento, come un abile tiratore scaglierebbe un motto degno di considerazione breve e conciso, in modo che l'interlocutore non farebbe miglior figura di quella che farebbe un bambino. Ci sono alcuni, fra i contemporanei e fra gli antichi, che hanno capito proprio questo, cioè che imitare gli Spartani consiste molto più nell'amare la sapienza che nell'amare la ginnastica, ben sapendo che l'essere capaci di pronunciare motti del genere è caratteristica dell'uomo che ha avuto una perfetta educazione spirituale. Tra questi vi furono Talete di Mileto, (73) Pittaco di Mitilene, (74) Biante di Priene, (75) il nostro Solone, (76) Cleobulo di Lindo, (77) Misone di Chene, (78) e settimo tra questi si contava Chilone di Sparta.(79) Tutti costoro furono fautori, amanti e discepoli dell'educazione spirituale spartana; e che la loro sapienza fosse di questa specie lo si può capire da quei motti brevi e memorabili proferiti da ciascuno.
Costoro, poi, ritrovatisi insieme, li offrirono come primizie di sapienza ad Apollo, nel tempio di Delfi, mettendo per iscritto le sentenze che sono sulla bocca di tutti: "Conosci te stesso" e "Nulla di troppo". Ma perché dico queste cose? Per far vedere che proprio in questo consisteva il metodo della filosofia degli antichi, vale a dire in una sorta di concisione spartana. E, in particolare, di Pittaco era noto il motto lodato dai sapienti: "Difficile è esser buono".
Simonide, dunque, ambizioso com'era di farsi onore nell'ambito della sapienza, capì che, se avesse atterrato questa massima, come si atterra un atleta famoso, e l'avesse superata, si sarebbe fatto un nome fra i contemporanei. Contro questa massima, dunque, e con questo scopo, con l'intento cioè di servirsene per abbatterla, compose, a mio avviso, l'intero carme. Esaminiamolo, dunque, tutti insieme, per verificare se quello che dico è vero. Già l'inizio del carme apparirebbe strano, se, volendo dire che è difficile diventare uomo buono, vi inserisse poi quel "bensì ". Questo "bensì ", infatti, apparirebbe inserito senza ragione, a meno che non si supponga che Simonide parli contestando la massima di Pittaco: mentre Pittaco afferma che è difficile essere buono, per contraddirlo lui dice che non lo è, "bensì , piuttosto, il difficile è diventare uomo buono, o Pittaco, veramente". E non intende "veramente buono": non è su questo concetto che egli parla di verità, come se ci fossero alcuni veramente buoni, e altri buoni, ma non veramente, perché questo sarebbe sciocco e indegno di Simonide. Bisogna invece, nel carme, trasporre quel "veramente", premettendogli, in un certo senso, la massima di Pittaco, come se immaginassimo che Pittaco in persona dicesse la sua e Simonide gli rispondesse, l'uno dicendo: "O uomini, è difficile essere buono", e l'altro rispondendo: "O Pittaco, non è vero quello che dici: non l'essere buono, bensì il diventare buono, di mani, di piedi e di cuore tetragono, costruito senza pecca, è veramente difficile". In questo modo, il "bensì " appare inserito a proposito, e il "veramente" va correttamente posto alla fine del verso.
E tutto quel che segue testimonia a favore di questa interpretazione, provando cioè che questo è il senso di ciò che si dice nel carme. Ed è possibile, anche su ciascuna affermazione del carme, provare ampiamente che esso è ben fatto: è, infatti, molto elegante ed accurato. Ma sarebbe troppo lungo analizzarlo in questo modo. Esaminiamo invece il suo impianto generale e il suo intento, che, nel corso dell'intero carme, è soprattutto quello di confutare il detto di Pittaco.
Dice infatti, procedendo di pochi versi, per dire in forma di prosa quello che lui dice, che diventare uomo buono è veramente difficile, ma che è tuttavia possibile, almeno per qualche tempo; ma, una volta divenuto tale, rimanere in questo stato e essere uomo buono, come tu dici, o Pittaco, è impossibile e non umano, ma un dio soltanto potrebbe avere questo privilegio: non può non essere cattivo l'uomo, che irrimediabile sventura abbia abbattuto.
Ebbene, chi è colui che viene abbattuto da irrimediabile sventura, al comando di una nave? è chiaro che non si tratta del profano, perché il profano è sempre abbattuto. Infatti, come non si può gettare a terra chi è già steso a terra, ma si può, prima o poi, gettare a terra chi invece è in piedi, in modo da stenderlo a terra, ma non lo si può fare, appunto, a chi è già steso a terra, così anche un'irrimediabile sventura può, una volta o l'altra, abbattere chi sia ricco di risorse, ma non chi sia, da sempre, povero di risorse.
E una violenta tempesta, abbattendosi sul nocchiero, può far sì che egli si trovi a corto di risorse, e una cattiva stagione, colpendo il contadino, può metterlo in condizione di essere povero di risorse, e lo stesso accade per il medico.
All'uomo buono, infatti, è possibile diventare cattivo, com'è testimoniato anche da un altro poeta, che dice: "del resto, l'uomo perbene talora è cattivo e talora è buono". Al cattivo, invece, non è possibile diventare cattivo: è necessario che lo sia sempre. Sicché l'uomo ricco di risorse, che è sapiente e che è buono, quando venga travolto da una irrimediabile sventura, non può non essere cattivo. Tu, Pittaco, affermi che è difficile essere buono: ma è il diventare buono che è difficile, e tuttavia possibile, mentre essere buono è impossibile: "quando ha buona sorte ogni uomo è buono; è invece cattivo quando ha cattiva sorte". Ma cosa porta, allora, al successo nelle lettere, e che cosa rende l'uomo abile nelle lettere? è chiaro: la conoscenza di esse. E che cosa porta un bravo medico ad avere successo? è chiaro che si tratta della conoscenza di come vadano curati i malati. è invece cattivo quando ha cattiva sorte. E chi può diventare cattivo medico?
Chiaramente chi, come prima condizione, sia medico; poi bisogna che sia un buon medico, perché costui potrebbe diventare anche cattivo. Ma noi, che di medicina siamo profani, non potremmo mai, per quanto cattiva sia con noi la sorte, diventare medici, né costruttori, né nulla di simile. E chi non può diventare medico, per quanto sfortunato sia, è chiaro che non può diventare neppure cattivo medico. Così anche l'uomo buono può diventare un giorno o l'altro, anche cattivo, per effetto del tempo, della fatica, di una malattia o di qualche altra circostanza.
Infatti, in questo solamente consiste l'avere cattiva sorte: nell'essere privato di conoscenza. L'uomo cattivo, quindi, non potrebbe mai diventare cattivo, perché lo è sempre; ma, se si vuole che diventi cattivo, bisogna prima che diventi buono. Sicché anche questo punto del carme mira a dimostrare che non è possibile essere uomo buono, mantenendosi tale, che è invece possibile diventare buono, e da buono diventare cattivo, e che sono migliori e buoni più a lungo coloro che gli dèi amano.
Tutte queste cose sono affermate contro Pittaco, e il seguito del carme lo fa vedere ancora meglio. Dice infatti: "Perciò mai io, cercando quel che è impossibile, getterò via, vana, la mia parte di vita correndo dietro a una speranza inutile, di trovare un uomo senza macchia tra quanti mangiamo il frutto dell'ampia terra, ma se dovessi trovarlo ve ne informerò". E dice - tanta è la forza con cui attacca la massima di Pittaco! -: "io lodo e amo chiunque volontariamente non compia nulla di male; ma contro la necessità neppure gli dèi combattono". Anche quest'affermazione mira allo stesso scopo.
Simonide, infatti, non era così sprovveduto da dire che egli lodava chiunque non facesse di sua volontà nulla di male, come se esistessero alcuni che fanno il male volontariamente. La mia opinione è, infatti, all'incirca questa: che nessuno dei sapienti ritiene che qualcuno volontariamente sbagli e commetta azioni turpi e cattive, ma essi ben sanno che tutti coloro che commettono azioni turpi e cattive, le commettono a dispetto della propria volontà; e, di certo, anche Simonide non dice di lodare chi non compia il male di sua volontà, ma dice questo "volontariamente" riferendosi a se stesso. Riteneva, infatti, che un uomo buono e onesto spesso costringe se stesso a diventare amico di qualcuno e a lodarlo, come spesso accade a qualcuno di fare verso una madre, un padre, una patria ostili, o in qualche altro caso del genere.
Ora, i malvagi, quando capita loro qualcosa del genere, guardano a questo come se ne fossero contenti e con rimproveri mettono in evidenza e sotto accusa la cattiveria dei genitori o della patria, perché la gente non possa poi accusarli se non si curano di loro né biasimarli del fatto di non prendersene cura, sicché li rimproverano ancora di più e aggiungono rancori volontari a quelli che necessariamente esistono. I buoni, invece, si costringono a far finta di niente e a lodarli, e anche se sono in collera coi genitori o con la patria per i torti ingiustamente ricevuti, s'impongono calma e si riconciliano con loro, sforzandosi di amarli e di lodarli. Anche Simonide, credo, spesso ritenne di dover lodare ed esaltare un tiranno o qualche altro individuo del genere non di sua volontà, ma costringendosi a farlo. E questo lo dice anche a Pittaco "Io, Pittaco, non ti biasimo per questo, perché trovo soddisfazione nel biasimare, poiché, quanto a me, mi basta chi non sia cattivo né troppo meschino, che conosca la giustizia utile alla città e sia uomo sano, e non lo biasimerò, perché non sono portato al biasimo, ché infinita è la progenie degli stolti; sicché, se uno prova piacere a biasimare, avrebbe di che saziarsi biasimando costoro". Belle sono tutte le cose che non hanno bruttura in sé mescolata.
E questo non lo dice come se dicesse che sono bianche tutte le cose alle quali non è mescolato il nero, perché una tale affermazione sarebbe ridicola sotto vari aspetti, ma lo dice intendendo che egli accetta anche le vie di mezzo, al punto di non biasimarle. "E non cerco", dice, "un uomo senza macchia tra quanti mangiamo il frutto dell'ampia terra, ma se dovessi trovarlo, ve ne informerò; sicché non loderò nessuno per questa impeccabilità, ma mi basta che uno sia una via di mezzo e non commetta nulla di male, visto che io amo e lodo tutti", e qui si serve della lingua degli abitanti di Mitilene, come se si rivolgesse a Pittaco quando dice: "amo e lodo chiunque volontariamente" (e qui, sul "volontariamente", bisogna fare una pausa) "non compia nulla di male, ma ce ne sono anche alcuni che io lodo e amo a dispetto della mia volontà. Quanto a te, Pittaco, anche se tu avessi detto cose solo a metà giuste e vere, non ti avrei mai rimproverato. Ma visto che ora ti pare di dire cose vere, pur ingannandoti in pieno e sulle questioni più importanti, per questo io ti biasimo". Questo, secondo me, o Prodico e Protagora», dissi, «è quello che Simonide aveva in mente nel comporre questo carme».
E Ippia disse: «Mi sembra, o Socrate, che anche tu abbia dato una buona interpretazione del carme. Anch'io, però, ho su di esso un'analisi ben fatta, che, se volete, vi esporrò».
E Alcibiade disse: «Certo, Ippia! Un'altra volta, però! Ora, invece, è giusto, come Protagora e Socrate avevano di comune accordo stabilito di fare, che sia Protagora a interrogare, se ancora lo vuole, e Socrate risponda, e se, invece, vuole essere lui a rispondere a Socrate, che sia l'altro a interrogarlo».
Ed io dissi: «Mi rimetto a Protagora, che sia lui a scegliere ciò che più gli garba. Ma, se vuole, lasciamo stare carmi e poesie.
Più volentieri, invece, o Protagora, cercherei di giungere a una conclusione circa le questioni su cui ti interrogai all'inizio, esaminandole con te. Ho l'impressione, infatti, che le disquisizioni sulla poesia siano molto simili ai banchetti di gente volgare e bassa.
Costoro, infatti, per la loro incapacità di fare conversazione, durante il banchetto, con risorse proprie e di comunicare per mezzo della propria voce e dei propri discorsi, per effetto della loro mancata educazione, fanno rincarare le suonatrici di flauto, pagando a caro prezzo una voce estranea, quella dei flauti, e attraverso la voce dei flauti s'intrattengono fra di loro. Dove ci sono, invece, commensali virtuosi e perbene, ed educati nello spirito, non potresti vedere né suonatrici di flauto, né danzatrici né citaredi, ma costoro bastano a se stessi per conversare, senza queste frivolezze e senza questi trastulli, con la propria voce, parlando e ascoltando ciascuno al suo turno, con ordine, anche quando bevano molto vino. Così , anche queste nostre riunioni, se davvero accolgono uomini quali la maggior parte di noi afferma di essere, non hanno alcun bisogno di una voce estranea né della voce dei poeti, a cui non si possono fare domande sulle cose che dicono. E i più, quando la discussione cade su un punto che non sono in grado di ribattere, essi, citando a testimoni i poeti nel corso del ragionamento, danno, del pensiero del poeta, chi un'interpretazione, chi un'altra. Ma gli uomini per bene lasciano stare gli intrattenimenti di questo tipo, e conversano fra di loro con risorse proprie, mettendosi l'un l'altro alla prova nei loro discorsi. Sono costoro, a parer mio, che io e te dobbiamo piuttosto imitare, e bisogna che, mettendo da parte i poeti, discutiamo tra noi coi nostri ragionamenti, mettendo alla prova la verità e noi stessi. E se tu vuoi ancora interrogarmi, sono pronto a risponderti, oppure, se vuoi, concedimi di dare una conclusione a quegli argomenti che abbiamo smesso di analizzare nel bel mezzo».
Al mio dire queste e altre cose di questo genere, Protagora non dava alcun chiaro segno da cui si potesse capire quale delle due cose avrebbe fatto. Alcibiade, allora, rivolgendosi a Callia, disse: «Callia, ti pare anche adesso che Protagora si comporti bene, non volendo dichiarare se è disposto oppure no a rendere conto delle proprie affermazioni? A me non pare! Ma si metta a discutere, o dichiari di non voler discutere, in modo che anche noi possiamo saperlo e Socrate possa discutere con qualcun altro, o chiunque ne abbia voglia con altri».
E Protagora, vergognandosi, almeno così parve a me, a queste parole di Alcibiade e alle preghiere di Callia e di quasi tutti gli altri presenti, malvolentieri si decise a discutere e mi chiese di interrogarlo dichiarandosi disposto a discutere.
Ed io, allora, dissi: «O Protagora, non pensare che io discuta con te con altro scopo che non sia quello di vedere chiaro nelle cose su cui anch'io mi trovo, ogni volta, in difficoltà. Ritengo, infatti, che Omero dica una gran verità in quel verso che recita: "quando due vanno insieme, uno vede prima dell'altro", (80) perché così noi tutti siamo, in un certo senso, più ben disposti ad ogni azione, discorso e pensiero. Uno solo, invece, per quanto pensi, (81) va subito a cercare qualcuno a cui possa mostrare il suo pensiero e con l'aiuto del quale possa consolidarlo, finché non lo trovi. Ed è per questo che anch'io discuto più volentieri con te che con chiunque altro, perché penso che tu abbia già esaminato nel migliore dei modi quelle altre questioni che sono il naturale campo di indagine dell'uomo per bene, e così la questione della virtù. Del resto, chi altri se non te? Tu, infatti, non solo pensi di essere un uomo per bene, come certi altri che sono sì , per quanto li riguarda, per bene, ma non sono capaci di rendere tali anche altri; tu, invece, sei personalmente uomo buono e sei capace di rendere buoni anche altri, e hai tanta fiducia in te stesso che, mentre gli altri tengono nascosta quest'arte, tu apertamente ti sei fatto annunciare, con tanto di banditore, a tutti i Greci, ti sei dato il nome di sofista, ti sei presentato come maestro di educazione e di virtù, e sei stato il primo a pretendere il diritto di ricevere un compenso per questo. Come si fa, dunque, a non chiamarti in aiuto quando si tratta di indagare su queste cose, a non interrogarti e a non coinvolgerti? Non c'è modo di evitarlo. Ebbene io, ora, a proposito delle domande che all'inizio ti feci su questo argomento, desidero che certune vengano da te richiamate alla memoria, cominciando dal principio, e che certe altre, invece, vengano analizzate da noi due insieme. E la domanda, se non erro, era questa: sapienza, temperanza, coraggio, giustizia e santità, essendo cinque diversi nomi, si riferiscono ad un'unica cosa, o a ciascuno di questi nomi corrisponde un'entità particolare e una cosa avente, ciascuna, una funzione che le è propria, senza che l'una sia uguale all'altra? Tu sostenevi che non si trattava di nomi riferiti ad un'unica cosa, ma che ciascuno di questi nomi corrispondeva a una cosa particolare, e che tutte queste erano parti della virtù, non come le parti dell'oro che sono simili l'una all'altra e al tutto di cui sono parti, ma come le parti del volto, che sono diverse l'una dall'altra e dal tutto di cui sono parti, ciascuna con una sua particolare funzione. Ebbene, dimmi se su queste cose la pensi ancora come allora; se, invece, la pensi in qualche altro modo, specifica in che modo, confidando che io non te ne farò un aggravio, se tu ora sosterrai qualche altra cosa: non sarei affatto stupito, infatti, se tu avessi fatto, allora, queste affermazioni solo per mettermi alla prova».
«Ma io, o Socrate», rispose, «ti dico che tutte queste sono parti della virtù, e che quattro di esse sono abbastanza simili fra loro, mentre il coraggio è affatto diverso da ciascuna di esse. E la prova che io dico il vero potrai averla da questo: troverai, infatti, molti uomini che sono sommamente ingiusti, empi, dissoluti e ignoranti e che sono, nondimeno, straordinariamente coraggiosi».
«Fermati qui», dissi. «Merita di essere analizzata questa tua affermazione. I coraggiosi tu li chiami audaci, o che altro?» «E intrepidi, anche», rispose, «a gettarsi in quelle imprese che i più temono di affrontare». «Su, dimmi, tu sostieni che la virtù è qualcosa di bello, e appunto nella convinzione che sia bella ti presenti come maestro di essa?»
«Bellissima davvero», rispose, «a meno che io non sia pazzo». «E credi», continuai, «che una parte di essa sia brutta e un'altra bella, o che sia tutta bella?» «Tutta bella, e in sommo grado». «Sai chi sono coloro che si tuffano nei pozzi con audacia?» «Sicuro! I palombari». «E lo fanno perché ne hanno conoscenza, o per qualche altro motivo?» «Perché ne hanno conoscenza». «E chi sono coloro che combattono da cavallo con audacia? Sono coloro che hanno pratica di cavalcare, o coloro che non ne hanno pratica alcuna?» «Quelli che hanno pratica di cavalcare».
«E chi sono coloro che combattono con audacia reggendo la pelta? Sono o non sono i peltasti?» (82) «I peltasti. E in tutti gli altri casi, se è questo che cerchi di sapere», rispose, «coloro che hanno conoscenza sono più audaci di coloro che non hanno conoscenza, ed essi stessi sono più audaci, dopo aver imparato, di quanto non fossero prima di imparare».
«E ne hai già visti», dissi, «di quelli che, pur non avendo conoscenza di alcuna di queste cose, sono tuttavia audaci nell'affrontare ciascuna di esse?» «Sì », rispose, «e fin troppo audaci!». «Questi audaci sono anche coraggiosi?» «Brutta cosa davvero», rispose, «sarebbe allora il coraggio, visto che costoro sono fuori di senno!». «Come definisci, allora», dissi, «i coraggiosi? Non definivi coraggiosi gli audaci?» «E così li definisco tuttora», rispose. «Ma costoro», dissi, «che sono audaci in questo modo, non danno l'impressione, forse, di non essere coraggiosi, bensì pazzi? E non si diceva prima che coloro che ne sanno di più sono anche i più audaci, e che essendo i più audaci sono anche i più coraggiosi? E, secondo questo ragionamento, la sapienza non si identifica forse col coraggio?» «Non ricordi bene, Socrate», disse, «quello che dicevo e le risposte che ti davo. Alla tua domanda se i coraggiosi sono audaci, ammisi che era così ; ma non mi è stato chiesto se anche gli audaci siano coraggiosi.
E se tu me l'avessi chiesto, ti avrei risposto che non tutti lo sono.
E, d'altra parte, non hai in alcun modo dimostrato che i coraggiosi non sono audaci, cosa che avevo ammesso, e che la mia affermazione non è giusta. Poi, tu dichiari che coloro che hanno conoscenza sono più audaci rispetto a se stessi, a com'erano cioè quando non avevano ancora conoscenza, e rispetto ad altri che non hanno conoscenza, e con questo giungi a credere che il coraggio e la sapienza sono la stessa cosa. Procedendo in questo modo, però, potresti anche arrivare a credere che forza e sapienza sono la stessa cosa. Infatti se, seguendo questo procedimento, mi domandassi, come prima cosa, se i forti sono potenti, ti risponderei di sì ; poi, se tu mi domandassi se coloro che sanno combattere sono più potenti di coloro che non sanno combattere, e se sono, rispetto a se stessi, più potenti, dopo aver imparato, di quanto non fossero prima di imparare, io ti risponderei di sì ; e, una volta che io abbia ammesso queste cose, ti sarebbe possibile, servendoti di queste stesse affermazioni come prove, sostenere che, per mia ammissione, la sapienza si identifica con la forza. Ma io, né qui né altrove, ammetto che i potenti sono forti, bensì ammetto che i forti sono potenti.
Non sono infatti la stessa cosa potenza e forza: l'una, vale a dire la potenza, deriva dalla conoscenza, e anche dalla pazzia e dall'avere un animo ardente, mentre l'altra, cioè la forza, deriva dalla natura e dall'avere un corpo ben nutrito.
Così , anche nel nostro caso, non sono la stessa cosa audacia e coraggio, sicché accade che i coraggiosi sono audaci, ma non tutti gli audaci sono coraggiosi. L'audacia, infatti, come la potenza, deriva agli uomini da un'arte, dall'avere un animo ardente e dalla pazzia, mentre il coraggio deriva dalla natura e dall'avere un'anima ben nutrita».
«Tu dici, Protagora», dissi, «che alcuni uomini vivono bene e altri male?». Disse di sì . «E ti pare forse che un uomo viva bene, se vive nella sofferenza e nel dolore?». Disse di no. «E che ne dici, se uno arriva alla fine della sua vita, dopo aver vissuto piacevolmente?
Non ti sembra che, in tal caso, abbia vissuto bene?» «Mi sembra di sì », disse. «E allora, vivere piacevolmente è un bene, mentre vivere spiacevolmente è un male». «Sì », rispose, «purché si viva provando piacere alle cose belle». «Che c'è, Protagora? Non chiamerai anche tu, come fa la maggior parte della gente, piacevoli certe cose che sono cattive, e spiacevoli certe cose che sono buone? Infatti, io dico: le cose, in quanto sono piacevoli, non sono forse, proprio in virtù di questo, buone, se non si considerano altri effetti che da esse potrebbero derivare? E, d'altra parte, le cose spiacevoli, allo stesso modo, non sono forse cattive, in quanto sono spiacevoli?» «Non so, Socrate», rispose, «se ti debbo dare una risposta tanto semplice quanto la domanda che tu poni, e dirti che le cose piacevoli sono tutte buone e quelle spiacevoli tutte cattive. Mi pare che sia più saggio rispondere considerando non solo la risposta da dare ora, ma tenendo conto anche di ciò che ho visto vivendo, e cioè che vi sono cose, fra quelle piacevoli, che non sono buone, e, d'altro canto, cose, fra quelle spiacevoli, che non sono cattive, e altre, invece, che lo sono; e, come terza affermazione, che vi sono cose che non sono né l'uno né l'altro, ossia né buone né cattive». «E non chiami piacevoli», dissi, «le cose che attingono al piacere o procurano piacere?» «Certo», disse.
«Ebbene, è proprio questo quello che intendo dire, quando ti chiedo se le cose, in quanto sono piacevoli, non siano buone: se il piacere non sia, in sé, un bene». «Come tu dici ogni volta, Socrate», disse, «esaminiamo la cosa; e, se il risultato dell'indagine ci sembrerà conforme al ragionamento, e piacere e bene risulteranno essere la stessa cosa, allora ci troveremo d'accordo ad ammetterlo, se no, continueremo ancora a sostenere tesi opposte».
«Preferisci», gli chiesi, «essere tu a guidare l'indagine, o vuoi che sia io a guidarla?» «è giusto», disse, «che sia tu a guidarla, visto che sei stato tu a cominciare il discorso».
«Ebbene», dissi, «non potremmo chiarire la cosa in questo modo? Per fare un esempio, se si volesse stabilire, dall'aspetto esterno di un uomo, il suo stato di salute o qualche altra cosa che abbia a che vedere col corpo, dopo avergli guardato il volto e le estremità delle mani, gli si direbbe: "Su, ora spogliati e mostrami anche il petto e la schiena, perché possa esaminarti meglio". Anch'io desidero fare qualcosa del genere nell'interesse della nostra indagine. Dopo aver visto che la tua opinione sul bene e sul piacere è quella che tu dici, ho bisogno di dirti appunto una cosa di questo genere. "Su, Protagora, scoprimi anche questa parte del tuo pensiero: che opinione hai della conoscenza? Hai anche su questa la stessa opinione che ha la maggior parte della gente, o un'opinione diversa? La maggior parte della gente, infatti, ha sulla conoscenza press'a poco quest'opinione: che essa non abbia forza, né autorità, né capacità di comando. E non pensano ad essa come a una cosa che abbia queste caratteristiche, ma credono invece che, benché la conoscenza sia spesso presente nell'uomo, non sia essa a comandarlo ma qualcos'altro: talora la rabbia, tal altra il piacere, tal altra ancora il dolore, qualche volta l'amore, spesso la paura; insomma, considerano la conoscenza una sorta di schiava tirata in giro da tutte le altre passioni. Ebbene, hai anche tu una siffatta opinione su di essa, o pensi che essa sia una cosa bella e capace di comandare l'uomo; che, se uno ha conoscenza del bene e del male, non possa essere sopraffatto da alcunché, in modo da fare cose diverse da quelle che tale conoscenza gli impone di fare; e che la conoscenza sia efficace aiuto per l'uomo?"».
«La penso anch'io, o Socrate», rispose, «come hai appena detto; ma, al tempo stesso, per me più che per chiunque altro, non sta bene sostenere che la sapienza e la conoscenza non sono, di tutte le cose umane, le più potenti». «Parli bene», dissi, «ed è vero quello che dici. Sai, dunque, che la maggior parte della gente non crede né a me né a te, ma sostiene che molti, pur avendo conoscenza di ciò che è meglio, non lo vogliono fare, anche se è in loro potere farlo, ma fanno cose diverse.
E tutti coloro ai quali domandai quale ne sia la ragione, mi hanno detto che gli uomini che così si comportano, lo fanno perché vinti dal piacere, dal dolore, o da qualcuna delle passioni di cui ho appena parlato».
«Io credo, o Socrate», disse, «che gli uomini facciano anche molte altre affermazioni errate».
«Su, allora, cerca insieme a me di convincere gli uomini e di insegnare loro che cosa sia questo che succede loro, e che essi chiamano essere vinti dai piaceri e non fare, a causa di questo, ciò che è meglio, pur avendone conoscenza. Forse, se noi dicessimo loro: "Quello che dite non è giusto, o uomini, ma vi ingannate", essi, allora, ci domanderebbero: «O Protagora e Socrate, se questa cosa che ci succede non è l'essere vinti dal piacere, di che si tratta, allora, e che cosa voi dite che sia? Ditecelo!"».
«Ma che bisogno c'è, o Socrate, di mettersi a considerare l'opinione della maggior parte della gente, che dice, a caso, quello che le capita per la testa?» «Credo», risposi, «che questo in qualche modo ci servirà a scoprire che rapporto abbia il coraggio con le altre parti della virtù.
Se pensi che sia giusto restare fedele a quello che abbiamo appena stabilito, che cioè sia io a guidare l'indagine nel modo che, a mio giudizio, porti la massima chiarezza sulla questione, seguimi. Se invece non vuoi, e se questo ti sta a cuore, lascerò stare».
«Dici bene», rispose, «continua come hai cominciato!».
«Se, allora», dissi, «essi tornassero a chiederci: "Che cosa dite voi che sia questa cosa che noi definivamo l'essere vinti dai piaceri?", io darei loro questa risposta: "State a sentire! Io e Protagora cercheremo di spiegarvelo. Non dite forse che vi accade proprio questo, e non altro, in questi casi, quando cioè spesso, sopraffatti dai cibi, dalle bevande e dagli stimoli sessuali, pur sapendo che sono cose cattive, tuttavia le fate?» «Risponderebbero di sì ». «Se, allora, io e te facessimo loro quest'altra domanda: "In che senso definite queste cose cattive? Perché sul momento procurano quel dato piacere e ciascuna di esse è piacevole, o perché in un secondo tempo provocano malattie e portano povertà e molte altre cose del genere? Oppure, se anche dopo non portassero con sé nessuna di queste conseguenze, e il loro effetto fosse solo quello di procurare piacere, sarebbero ugualmente cattive, qualunque sia la ragione e il modo del piacere che procurano?". Dobbiamo pensare, Protagora, che darebbero una risposta diversa da questa: che tali cose non sono mali per la produzione di questo piacere momentaneo, ma per gli effetti che in un secondo tempo ne derivano, malattie e tutto il resto?» «Penso», rispose Protagora, «che la maggior parte della gente darebbe questa risposta».
«"E portando malattie, non portano dolori, e, portando povertà, non portano dolori?". Si direbbero d'accordo, penso».
Protagora ne convenne. «"Non sembra, dunque, anche a voi, o uomini, come io e Protagora sosteniamo, che queste cose siano cattive non per altra ragione che perché vanno a finire in dolori e privano di altri piaceri?". Si direbbero d'accordo?». Ne convenimmo entrambi.
«E se facessimo loro la domanda opposta: "O uomini, quando dite che esistono cose buone che sono dolorose, non vi riferite forse a cose che, come gli esercizi ginnici, il servizio militare e le cure praticate dai medici con cauterizzazioni, tagli, medicine e digiuni, sono buone, ma spiacevoli?". Direbbero di sì ?». Lo ammise. «"E chiamate queste cose buone forse perché sul momento procurano dolori estremi e sofferenze, o perché in un secondo tempo da esse derivano salute e benessere dei corpi, salvezza delle città, potere sugli altri e ricchezze?".
Risponderebbero che è così , penso». Lo ammise. «"E queste cose sono forse buone per altra ragione che perché vanno a finire in piaceri, e liberano e difendono dai dolori? O potete citare qualche altro effetto, che non siano piaceri e dolori, guardando al quale chiamate buone queste cose?". Risponderebbero di no, credo». «Pare anche a me», disse Protagora, «che risponderebbero di no». «"E voi inseguite il piacere nella convinzione che sia un bene, e fuggite il dolore nella convinzione che sia un male?"». Lo ammise. «"Allora voi ritenete che questo, il dolore, sia un male, e che il piacere sia un bene, visto che dite che talora persino il godere è un male, quando privi di piaceri maggiori di quelli che porta con sé, o procuri dolori maggiori dei piaceri che comporta? Diversamente, se chiamate male persino il godere in qualche altro senso o guardando a qualche altro suo effetto, dovreste dircelo: ma non potreste farlo!"» «Anche a me pare che non potrebbero»~ disse Protagora. «"E ancora, che altro accade a proposito del soffrire, se non la stessa cosa? Non chiamate talora bene persino il soffrire, quando liberi da dolori maggiori di quelli che comporta, o procuri piaceri maggiori di questi dolori? Altrimenti, se guardate a qualche altro suo effetto, diverso da quello che dico io, quando chiamate bene persino il soffrire, dovete dircelo: ma non potrete farlo!"». «Quello che dici è vero», disse Protagora.
«E ancora, se voi, o uomini», dissi, «mi faceste quest'altra domanda: "Ma perché mai parli così a lungo, e considerandone tutti questi aspetti, di questo argomento?", io risponderei "Perdonatemi! In primo luogo, non e facile chiarire che cosa sia mai questa cosa che voi definite l'essere vinti dai piaceri; e poi da questo dipendono tutte le dimostrazioni successive. Ma potete ancora ritrattare, e vedere se vi riesce di dare qualche altra definizione di bene che non sia il piacere, e di male che non sia il dispiacere. O vi basta vivere piacevolmente la vita senza dolori? Se questo vi basta, e non potete dare, di bene e di male, altra definizione che non sia ciò che va a finire in piaceri e in dolori, state a sentire ciò che segue. Io vi dico che, se le cose stanno così , è un ragionamento ridicolo, il vostro, quando affermate che l'uomo, pur avendo conoscenza del male come tale, tuttavia, spesso, lo compie, benché sia in suo potere non compierlo, perché mosso e sopraffatto dai piaceri. E inoltre dite che l'uomo, pur avendo conoscenza del bene, non vuole compierlo, per via del piacere del momento, perché da essi sopraffatto". Che queste affermazioni siano ridicole, risulterà chiaro, se non ci serviremo di più nomi contemporaneamente: piacere e dolore, bene e male; ma, visto che le cose in questione sono risultate essere due, dobbiamo riferirci ad esse pure con due soli nomi, prima con bene e male, poi con piacere e dolore.
Stabilito dunque di fare così , diciamo che l'uomo, pur conoscendo il male come tale, tuttavia lo compie. E qualora uno ci chieda: "Perché?", "Perché sopraffatto", risponderemo noi.
"E sopraffatto da che cosa?", costui allora ci chiederà. E noi non potremo più rispondere "dal piacere", perché la cosa, al posto di piacere, ha preso un altro nome, vale a dire quello di bene. E allora gli dovremo rispondere e dire: "Perché vinto...". "Vinto da che cosa?", chiederà. "Dal bene", dovremo dire, per Zeus! E allora, se ci capiterà, come interlocutore, uno sfacciato, costui se la riderà e dirà: "Che cosa ridicola state dicendo: voi affermate che uno compie il male, pur sapendo che è male, e senza che ci sia bisogno di farlo, perché sopraffatto dal bene! Lo affermate forse perché il bene, in voi, non è all'altezza di vincere il male, o perché ne è all'altezza?". Ovviamente dovremo rispondergli che questo accade perché il bene non ne è all'altezza! E infatti, se così non fosse, non avrebbe torto colui che noi diciamo essere sopraffatto dai piaceri! "E in che senso", forse ci chiederà, "i beni non sono all'altezza dei mali, o i mali dei beni? In che altro senso, se non quando gli uni siano più grandi degli altri e gli altri più piccoli, o gli uni più numerosi e gli altri inferiori di numero?". Non potremo dargli altra risposta che questa. "E allora è evidente", dirà, "che questa cosa che chiamate essere sopraffatti consiste nello scegliere mali più grandi invece di beni più piccoli". Così stanno le cose! Ebbene, cambiamo di nuovo i nomi, mettendo alle stesse cose i nomi di piacere e di dolore, e diciamo che l'uomo compie ciò che è doloroso (prima dicevamo "il male", ora invece diciamo pure "ciò che è doloroso"), pur avendone conoscenza come di cosa dolorosa, perché vinto dai piaceri, i quali, d'altro canto, è evidente che non sono all'altezza di vincere. E in che altro può consistere l'inferiorità del piacere rispetto al dolore, se non in un eccesso o in difetto dell'uno rispetto all'altro? E questo, poi, accade quando queste cose sono, le une rispetto alle altre, più grandi o più piccole, più numerose o meno numerose, superiori o inferiori.
E se uno dicesse: "Ma c'è gran differenza, Socrate, fra il piacere del momento e il piacere e il dolore futuri!", gli risponderei: "Sta forse in qualcos'altro la differenza, che non sia piacere e dolore? La differenza, infatti, non può consistere in altro! Tu, piuttosto, come uno abile a pesare, messi insieme i piaceri da una parte e i dolori dall'altra, dopo aver posto sul piatto della bilancia anche la vicinanza e la lontananza, prova a dire quale piatto è più pesante.
Se peserai piaceri con piaceri, dovrai sempre scegliere quelli più grandi e più numerosi; se peserai, invece, dolori con dolori, dovrai sempre scegliere quelli meno numerosi e più piccoli; se, poi, peserai piaceri con dolori, qualora i dolori siano superati dai piaceri, sia che i dolori vicini siano superati dai piaceri lontani, sia che i dolori lontani siano superati dai piaceri vicini, l'azione in cui vi sia questa condizione di superiorità del piacere sul dolore va allora compiuta. Quando, invece, siano i piaceri ad essere superati dai dolori, quelle azioni non le dovrai compiere. O le cose stanno in altro modo, uomini?", domanderei. So bene che non potrebbero dire altrimenti!».
Anch'egli fu d'accordo.
«"E visto che le cose stanno così ", dirò, "rispondete a questa mia domanda: le medesime grandezze appaiono alla vista maggiori da vicino, e minori da lontano. Non è così ?"» «Risponderanno di sì ».
«"E non accade lo stesso con le cose grosse e con le cose numerose?
E voci uguali non sembrano più forti da vicino, e più deboli da lontano?"» «Direbbero di sì ». «"Se, dunque, la nostra felicità dipendesse dal fare e scegliere le cose di grandi dimensioni e dal fuggire ed evitare le cose di piccole dimensioni, in che consisterebbe allora la salvezza della nostra vita? Nell'arte di misurare o nella forza dell'apparenza? O quest'ultima non ci trarrebbe forse in inganno e non ci farebbe più volte mutare le stesse cose e pentirci, sia nel compiere sia nello scegliere le cose grandi e le cose piccole, mentre l'arte dì misurare renderebbe impotente quest'illusione, e, mostrando la verità, metterebbe l'anima in pace, saldamente fedele al vero, e salverebbe la nostra vita?". Ebbene, non ammetterebbero gli uomini che, in questo senso, è l'arte di misurare che ci salva, o direbbero che si tratta di un'altra arte?» «Ammetterebbero che si tratta dell'arte di misurare», riconobbe.
«"E che accadrebbe, se la salvezza della nostra vita dipendesse dalla scelta del dispari e del pari, quando, per scegliere correttamente, dovessimo scegliere il più e quando il meno, sia valutando una data cosa rispetto a se stessa, sia valutando le cose una rispetto all'altra, che sia vicina e che sia lontana? Che cosa salverebbe, allora, la nostra vita? Non si tratterebbe forse di una data conoscenza? E non si tratterebbe di una conoscenza della misurazione, visto che si tratta di un'arte dell'eccesso e del difetto? E visto che si tratta dell'arte del dispari e del pari, potrebbe forse essere arte diversa dall'aritmetica?". Si direbbero d'accordo con noi, costoro, o no?». Anche Protagora fu dell'opinione che sarebbero stati d'accordo. «"E sia, gente! Poiché la salvezza della nostra vita è risultata dipendere dalla corretta scelta del piacere e del dolore, della quantità maggiore e minore, del più grande e del più piccolo, del più lontano e del più vicino, non vi pare innanzi tutto che non può non essere un'abilità nel misurare, visto che si tratta di una ricerca dell'eccesso, del difetto e dell'uguaglianza di una cosa rispetto ad un altra?"». «Per forza». «"E visto che si tratta di un'abilità nel misurare, deve per forza trattarsi di un'arte e di una conoscenza"». «Si diranno d'accordo». «"Di quale arte e di quale conoscenza si tratti, vedremo un'altra volta. Ma che si tratti di una conoscenza è quanto basta per la dimostrazione che io e Protagora dobbiamo darvi circa le cose che ci domandaste.
Ci avete posto questa domanda, se ricordate, quando noi due sostenemmo di comune accordo che non esiste nulla di più potente della conoscenza, e che essa sempre prevale, ovunque sia presente, sia sul piacere sia su tutte le altre passioni. Ebbene, voi affermaste che spesso il piacere prevale anche sull'uomo che ha conoscenza, e, dato che non vi demmo ragione, dopo questo ci chiedeste: "Protagora e Socrate, se questo che ci succede non è l'essere vinti dal piacere, di che si tratta, allora, e cosa dite che sia?
Ditecelo!". Se allora vi avessimo subito risposto: "Ignoranza", ci avreste riso in faccia. Ora, invece, se rideste di noi, ridereste anche di voi stessi, poiché anche voi avete ammesso che chi sbaglia nella scelta dei piaceri e dei dolori (cioè dei beni e dei mali), sbaglia per difetto di conoscenza; e non solo di conoscenza in generale, ma di quella conoscenza che, ancor prima, avete riconosciuto come conoscenza della misurazione. E l'azione errata commessa per difetto di conoscenza, sapete anche voi che si commette per ignoranza. Sicché, in questo consiste l'essere succubi del piacere: nella somma ignoranza, male di cui il nostro Protagora dice di essere medico, e così anche Prodico e Ippia. Ma voi, convinti che si tratti di altro dall'ignoranza, non andate e non mandate i vostri figli da quelli che insegnano queste cose, dai sofisti qui presenti, nella convinzione che esse non si possano insegnare: poiché vi preme il denaro e non lo volete spendere con costoro, riuscite male e nella vita privata e in quella pubblica".
Questa è la risposta che noi daremmo alla gente. Quanto a voi, Prodico e Ippia, perché anche voi dovete prendere parte alla discussione, insieme a Protagora vi domando se vi pare che le cose che dico siano vere o false». Tutti furono del parere che ciò che si era detto fosse fin troppo vero. «Allora», dissi, «ammettete che il piacere sia bene, e il dolore sia male. E scongiuro il nostro Prodico di risparmiarci la sua distinzione dei termini: sia che tu dica piacere, sia che tu dica divertimento, sia che tu dica godimento, sia che tu lo chiami prendendo il nome da dove ti pare e come ti fa piacere chiamarlo, caro Prodico, rispondimi sulla cosa che mi preme sapere». Ridendo, Prodico si disse d'accordo, e gli altri con lui. «Ebbene, gente», dissi, «che ne dite di questo? Tutte le azioni che mirano a questo scopo, ossia a vivere senza dolore e piacevolmente, non sono forse belle? E l'azione bella non è forse anche buona e utile?».
Ne convennero. «E allora», dissi, «se il piacere si identifica col bene, nessuno che sa o crede di sapere che altre cose sono migliori di quelle che fa, e che è in suo potere farle, continua tuttavia a fare queste, pur potendo farne di migliori. E l'essere succubi di se stessi non è altro che ignoranza, mentre il sapersi dominare non è altro che sapienza». Tutti ne convennero. «Ebbene, non dite forse che l'ignoranza consiste proprio in una cosa del genere, nell'avere una falsa opinione e nell'ingannarsi sulle cose di grande valore?». Anche su questo furono tutti d'accordo. «E non è forse vero», dissi, «che nessuno di sua volontà mira al male o a ciò che considera male, e che non è, a quanto pare, nella natura umana tendere volontariamente a ciò che si considera male invece che al bene; e che, quando si fosse costretti a scegliere fra due mali, nessuno sceglierà il male maggiore, se gli sarà possibile scegliere il minore?». Tutto ciò incontrò unanime consenso. «Ora», dissi, «c'è qualcosa che chiamate timore e paura? è forse la stessa cosa che intendo io? Parlo con te, Prodico! Intendo una sorta di aspettazione del male, che la chiamiate paura o la chiamiate timore». A Protagora e a Ippia parve che timore e paura consistessero proprio in questo, mentre Prodico era del parere che in questo consistesse il timore, ma non la paura. «Non ha nessuna importanza», dissi, «Prodico. Ciò che conta, piuttosto, è questo: se sono vere le precedenti affermazioni, ci sarà forse qualcuno che di sua volontà muoverà verso ciò di cui ha timore, pur essendogli possibile evitarlo? Non è forse impossibile, tenendo conto di quello che abbiamo prima convenuto? Si è convenuto, infatti, che le cose di cui uno ha timore sono da lui considerate mali; e che nessuno di sua volontà prende di mira o sceglie le cose che considera mali». Anche su questo furono tutti d'accordo. «Gettate queste fondamenta, o Prodico e Ippia», dissi, «il nostro Protagora difenda, di fronte a noi, le sue precedenti risposte, provando che sono corrette. Non le risposte che diede proprio all'inizio della discussione: allora, infatti, sostenne che, essendo cinque le parti della virtù, nessuna di esse è uguale all'altra, e che ciascuna ha una sua particolare funzione. Ma non è questa la risposta a cui mi riferisco, bensì alla sua affermazione successiva. Poco dopo, infatti, dichiarò che quattro di queste parti sono abbastanza simili tra loro, ma che una, il coraggio, è molto diversa dalle altre, e che io avrei potuto capirlo da questa prova: "Troverai, Socrate, molti uomini che sono sommamente empi, ingiusti, dissoluti e ignoranti, eppure dotati di grande coraggio. E da questo capirai che il coraggio è molto diverso dalle altre parti della virtù".
E già allora, subito, rimasi molto stupito di quella risposta, ma ora che ho esaminato con voi la questione, ne sono ancora più stupito.
Gli chiesi, allora, se definisse i coraggiosi "audaci", e mi rispose: "E intrepidi, anche". Ricordi, Protagora, di avermi dato questa risposta?».
Lo ammise. «E dimmi», continuai, «verso che cosa tu dici che i coraggiosi sono intrepidi? Verso le stesse cose a cui lo sono i vili?». Disse di no.
«Verso altre cose, allora!». «Sì », rispose. «E non accade forse che i vili affrontino imprese sicure, e i coraggiosi,invece, imprese rischiose?» «Così dice la gente, Socrate!». «Quello che dici», dissi, «è vero, ma non era questa la mia domanda, bensì che cosa sia, a tuo giudizio, ciò verso cui i coraggiosi sono intrepidi. Sono intrepidi verso le imprese rischiose, pur considerandole rischiose, o verso quelle imprese che rischiose non sono?» «Ma questo», rispose, «nei ragionamenti che hai appena fatto si è dimostrato impossibile!». «Anche in questo», dissi, «dici il vero. Sicché, se la dimostrazione è corretta, nessuno affronta imprese che considera rischiose, visto che l'essere succubi di se stessi si è scoperto essere ignoranza». Lo ammise. «Ma tutti, invece, vili e coraggiosi, affrontano le imprese sicure, e, almeno in questo, vili e coraggiosi affrontano le stesse imprese». «Però, Socrate», rispose, «è del tutto opposto ciò che affrontano i vili rispetto a ciò che affrontano i coraggiosi: per esempio alla guerra, questi vogliono andare, e quelli non vogliono».
«E andare alla guerra», domandai, «è un'azione bella o brutta?» «Bella», rispose. «E se è vero che è bella», dissi, «è anche buona: così abbiamo convenuto nei precedenti ragionamenti». «è vero quello che dici, e io sono sempre della stessa opinione». «Bene!», dissi. «Ma chi sono, secondo te, coloro che non vogliono andare alla guerra, benché essa sia un'azione bella e buona?» «I vili», rispose. «E se è bella e buona», chiesi, «non è forse anche piacevole?» «Almeno così si è stabilito», rispose. «E i vili non vogliono affrontare ciò che è più bello, più buono e più piacevole, nella consapevolezza che è tale?» «Ma anche in questo caso, se ammettiamo ciò», rispose, «mandiamo in malora quello che abbiamo prima convenuto!».
«E che dire del coraggioso? Non affronta forse ciò che è più bello, più buono e più piacevole?» «Bisogna ammetterlo!», rispose. «In generale, allora, i coraggiosi, quando hanno paura, non hanno brutte paure, né, quando sono audaci, hanno brutte audacie». «è vero», disse. «E se queste non sono brutte, non sono forse belle?». Lo ammise. «E se sono belle, sono anche buone?» «Sì ». «E, al contrario, i vili, gli audaci e i pazzi, non hanno forse brutte paure e brutte audacie?». Lo ammise.
«E sono audaci in cose brutte e cattive per altra ragione che non sia per incoscienza e per ignoranza?» «Così stanno le cose», rispose. «E allora? Quello per cui i vili sono vili, lo chiami viltà o coraggio?» «Lo chiamo viltà», disse. «Ma i vili non risultarono essere tali a causa della loro ignoranza delle cose che incutono timore?» «Certo», disse. «E allora a causa di questa ignoranza che sono vili?».
Lo ammise. «Ma non hai già ammesso che ciò per cui sono vili è la viltà?».
Disse di sì . «E, allora, l'ignoranza delle cose temibili e delle cose non temibili non risulta identificarsi con la viltà?».
Annuì . «Ma il contrario della viltà è il coraggio», dissi. Consentì . «E la conoscenza delle cose temibili e delle cose non temibili non è forse contraria all'ignoranza di esse?». Anche qui fece cenno di sì . «E l'ignoranza di queste cose non è la viltà?». Qui annuì piuttosto a malincuore. «La conoscenza delle cose temibili e delle cose non temibili non è allora il coraggio, essendo contraria all'ignoranza di esse?». Qui non volle più nemmeno annuire e restò in silenzio. Ed io: «Che c'è, Protagora: non rispondi né sì né no alla mia domanda?» «Continua da solo», disse. «Sì », dissi, «ma dopo averti fatto ancora una sola domanda, se cioè sei ancora del parere, come al principio della discussione, che esistano uomini in sommo grado ignoranti, eppure coraggiosissimi». «Ho l'impressione, o Socrate», rispose, «che tu ti accanisca a farmi rispondere. E allora ti faccio un favore e ti rispondo che, da quanto s'è convenuto, mi risulta che questo sia impossibile».
«Ma io», dissi, «non ti faccio tutte queste domande con altro scopo che quello di indagare come stiano le cose a proposito della virtù e che cosa mai sia in sé la virtù. So, infatti, che, fatta luce su questo punto, si chiarirebbe anche la questione su cui tu ed io abbiamo fatto ciascuno un gran parlare, io sostenendo che la virtù non è insegnabile, tu, invece, che è insegnabile. E sono convinto che l'esito dei nostri discorsi di poco fa, se potesse prendere aspetto umano, ci accuserebbe e si farebbe beffe di noi; e, se potesse parlare, immagino ci direbbe: "Siete ben strani, Socrate e Protagora: tu, Socrate, che nei tuoi ragionamenti di prima sostenevi che la virtù non è insegnabile, ora ti impegni a sostenere la tesi opposta, tentando di dimostrare che tutti i beni, giustizia, temperanza e coraggio, sono conoscenza, che è il modo migliore per far apparire insegnabile la virtù.
Perché se la virtù fosse altro dalla conoscenza, come Protagora tenta di dimostrare, sarebbe evidente che non si può insegnare. Ma se ora risultasse essere interamente costituita da conoscenza, come tu, Socrate, ti affanni a provare, sarebbe ben strano che non potesse essere insegnata.
Protagora, dal canto suo, che partiva dal presupposto che essa fosse insegnabile, ora, al contrario, pare ansioso di dimostrare che essa è tutto fuorché conoscenza; e, se così fosse, non risulterebbe affatto insegnabile". Ebbene, Protagora, vedendo tutto questo in tremendo scompiglio, ho un gran desiderio che si faccia chiarezza in queste questioni, e vorrei che, dopo averle esaminate, arrivassimo a capire che cosa sia la virtù, e che poi, di nuovo, tornassimo ad esaminare, a proposito di essa, se sia insegnabile o non lo sia, perché non capiti che l'Epimeteo di cui si parlava, ingannandoci, non ci mandi fuori strada anche nella nostra indagine, come già ci ha trascurati nella distribuzione, stando al tuo racconto. A dire il vero, anche nel mito Prometeo mi è piaciuto più di Epimeteo, ed io, facendo tesoro del suo caso e cercando di essere previdente (83) in tutti gli aspetti della mia vita, mi occupo appunto di tutte queste questioni; e, se tu volessi, come ti dissi anche all'inizio, sarei ben contento di esaminarle con te».
E Protagora: «Socrate, lodo il tuo zelo e la tua maniera di sviluppare il ragionamento. Non credo, neppure nel resto, di essere un cattivo uomo, ma penso di essere meno di ogni altro invidioso, visto che, anche di te, ho già detto a molti che, fra quelli in cui mi accade d'imbattermi, tu sei quello che io stimo di gran lunga di più, e in modo particolare rispetto ai tuoi coetanei. E dico, anzi, che non sarei affatto stupito se tu entrassi nel novero degli uomini illustri per sapienza. Ma di questo ne parleremo un'altra volta, quando vorrai. Ora è ormai tempo che mi metta a fare altre cose». «Ma via», dissi, «così bisogna fare, se così a te pare. Anche per me, del resto, è già da un pezzo ora di andare dove dissi che dovevo andare, ma ero rimasto per fare un piacere al bel Callia».
Detto e udito ciò, ce ne andammo.
NOTE:
1) Alcibiade visse all'incirca fra il 450 e il 404 a.C., anno in cui, dietro istigazione dei Trenta Tiranni e dello spartano Lisandro, venne assassinato in Frigia, dove si era rifugiato presso il satrapo Farnabazo dopo una vita avventurosa, costellata di mutamenti di alleanze, viaggi, successi e rovesci di fortuna. Fu figlio di Clinia, ateniese, della ricca e potente famiglia degli Eupatridi, e di Dinomache, appartenente anch'essa ad un'illustre stirpe ateniese, quella degli Alcmeonidi. Quando il padre morì , nel 446 a.C., Alcibiade, che all'epoca aveva circa quattro anni, venne affidato alla tutela di Pericle (cfr. Platone, Alcibiades 118c), con cui era imparentato. Secondo quanto attesta Platone nei dialoghi, frequentò a lungo Socrate: si veda soprattutto il Simposio (215a-219e).
2) Cfr. Omero, Iliade libro 24, verso 348; Odissea, libro 10, verso 279. La formula omerica «cui fiorisce la prima peluria, e la sua è la giovinezza più bella», da cui Platone prende gli elementi verbali senza citarla letteralmente, è riferita ad Ermes, che viene detto, nel primo caso, «simile ad un giovane principe», e, nel secondo, «simile ad un giovane eroe».
3) Alcibiade dovrebbe avere all'incirca 18 o 19 anni, se si suppone che l'azione del dialogo sia immaginata avvenire all'epoca del secondo viaggio di Protagora ad Atene, forse nel 432/31 a.C.
4) Cfr. Platone, Symposium 217a-219e: Alcibiade confessa di avere avuto una considerazione straordinaria del fiore della propria giovinezza e della propria bellezza e descrive i sentimenti che il fare sprezzante di Socrate agitava in lui: si sentiva rifiutato e tuttavia non sapeva privarsi della sua compagnia, e, dopo aver fallito con la propria avvenenza, si trovava privo di espedienti su come potesse conquistarlo.
5) Abdera è una città della Ionia, patria di Protagora, il cui nome verrà fatto fra poco. Di Abdera era anche Democrito.
6) Clinia, padre di Alcibiade (cfr. la nota 1), è menzionato da Erodoto, libro 8, 17, per essersi fatto onore nella battaglia navale dell'Artemisio contro i Persiani. E in battaglia morì , a Cheronea nel 446 a.C., quando Alcibiade aveva circa quattro anni.
7) Protagora nacque verso gli inizi del quinto secolo ad Abdera. Come tutti i sofisti viaggiò molto e fra il 450 e il 444 a.C. soggiornò una prima volta ad Atene, dove ebbe da Pericle l'incarico di preparare la legislazione per la nuova colonia panellenica di Turi; il secondo viaggio ad Atene è forse da collocare fra il 432 e il 431 a.C., epoca in cui probabilmente si immagina che avvenga l'azione del dialogo; stando a quel che Platone dice (Protagoras 349a), egli fu il primo a farsi pagare un compenso in denaro in cambio del sapere o di quell'arte "politica" di cui si professava maestro. Il fondamento del suo pensiero, espresso nello scritto La verità, viene citato dallo stesso Platone, Theaetetus 166d: «ciascuno di noi, in realtà, è misura delle cose che sono e di quelle che non sono, ma c'è una grande differenza tra l'uno e l'altro, proprio per questo, perché per uno esistono e appaiono certe cose, per un altro esistono e appaiono cose differenti».
Morì in naufragio nel 411 a.C., dopo aver lasciato Atene, dove era stato accusato di empietà per il suo libro Sugli dèi.
8) Personaggi altrimenti ignoti. Di Ippocrate figlio di Apollodoro sappiamo solo quello che di lui Platone dirà (316bc) per bocca di Socrate: ateniese, discendente di un casato potente e ricco, di buone doti naturali e ambizioso, e disposto a pagare qualsiasi prezzo purché Protagora gli trasmetta la propria sapienza. Sappiamo inoltre che all'epoca del primo soggiorno ad Atene di Protagora, fra il 450 e il 444 a.C., Ippocrate era, o si immagina che fosse, ancora un fanciullo (cfr. 310e).
9) Enoè era il nome di due demi attici, uno a nord e uno a nord-ovest di Atene. Qui si tratterà più probabilmente del secondo, essendo di lì più facile raggiungere la Beozia, probabile mèta di uno schiavo in fuga.
10) Sul tema dei sofisti "venditori" del loro sapere, cfr. più avanti 313c seguenti. e 328b-c.
11) Il primo viaggio di Protagora ad Atene è collocato intorno al 450-444 a.C.
12) Callia era uno dei più ricchi ateniesi, prima di dissipare il suo patrimonio col suo mecenatismo. La sua casa era albergo per i sofisti di passaggio, di cui egli era fanatico ammiratore. Cfr. la nota 66.
13) Ippocrate di Cos visse tra il 460 e il 370 a.C. circa. Discendeva dalla corporazione medica degli Asclepiadi di Cos. Sotto il suo nome è stata tramandata una raccolta di scritti medici in dialetto ionico, il Corpus Hippocraticum.
14) Policleto, nativo di Sicione ma chiamato argivo perché capo della scuola di scultura di Argo, visse ed operò nella seconda metà del quinto secolo. Ritraeva di preferenza giovani atleti, fra cui il Doriforo. il Diadumeno, l'Amazzone, ricostruendo il corpo umano sulla base di proporzioni matematico-geometriche che egli stesso fissò nel suo scritto sulla scultura, Il canone.
15) Il più celebre scultore greco. Operò intorno alla metà del quinto secolo, e fu amico di Pericle che gli commissionò le sculture per il Partenone, fra cui la statua crisoelefantina di Atena Parthenos, che nel 448 venne collocata nella cella grande del tempio. Nel 442 venne accusato dagli Ateniesi di essersi appropriato di una parte dell'oro destinato alla statua di Atena, e morì in carcere nel 431, vittima, come del resto anche Protagora e Anassagora, degli avversari politici di Pericle, che per colpire costui miravano a quelli della sua cerchia. Nel Menone (91d), per dare un'idea esagerata dei guadagni che Protagora traeva dall'arte sofistica, Platone fa dire a Socrate che Protagora, da solo, ha guadagnato più denaro da questa sapienza che non Fidia ed altri dieci scultori insieme.
16) Nel Sofista (223c-224e), Platone dimostra come l'«arte sofistica» si possa a ragione definire come il mestiere di compra e costruisce cognizioni e le scambia, da città a città, con denaro, traendo di che vivere da questa attività, e come questo ci autorizzi a chiamare mercante chi faccia di questo commercio il suo mestiere.
17) Ippia di Elide visse verso la fine del quinto secolo. Platone lo ritrae come un erudito che non perde occasione di sfoggiare il suo sapere enciclopedico (347a-b), e, facendolo zittire da Alcibiade, lascia intendere di non tenere in grande considerazione le sue disquisizioni. Vedi anche l'allusione di Protagora al tipo di insegnamento impartito da Ippia e dagli altri sofisti in 318e. Viaggiò molto ed ebbe un'intensa attività di poligrafo, letterato ed erudito. Platone lo rappresenta vanitoso e avido (cfr. Hippias maior 282d-e), presuntuoso esegeta di Omero (cfr. Hippia minor 364b-365c), e capace di fare di tutto. Sul paragone a Eracle, cfr. la nota 25.
18) Prodico di Ceo nacque fra il 470 e il 460 a.C. Fu ambasciatore in molte città, fra cui Atene, dove ottenne grande successo con le sue lezioni e, pare, ricavò favolose ricchezze (cfr. Platone, Hippias maior 282b-c). Scrisse le "Orai", che probabilmente contenevano l'apologo dì Eracle al bivio (riferito da Senofonte, Memorabilia libro 2, 1,20-34) sul tema moralistico delle due vie, la via della Mollezza, piana e piacevole, e la via della Virtù, segnata dal lavoro e dalla fatica (cfr. Esiodo, Opera et dies 286-92), e un trattato Sull'esattezza delle parole. Verrà rappresentato come un accanito censore dell'uso lessicale, che si fa scrupolo di precisare, ad ogni parola, il suo esatto significato (337a-c), e non resta per nulla soddisfatto da definizioni generali (358a). Socrate lo chiamerà ironicamente suo maestro (341a), e prenderà in giro il suo modo puntiglioso di fare sottilissime distinzioni semantiche, raccontando come Prodico lo rimproverava di usare a sproposito le parole (341a-b), e servendosi di lui per una assurda interpretazione della parola «difficile» in Simonide di Ceo, prontamente smascherata da Protagora (341b-d).
19) Paralo era fratello uterino di Callia. La madre di Callia, dopo essersi divisa da Ipponico, aveva sposato in seconde nozze Pericle, da cui ebbe i figli Paralo e Santippo, morti nella peste del 429 a.C. il fatto che Platone faccia figurare questi due personaggi fra gli ospiti di Callia in occasione del soggiorno ateniese dì Protagora lascia intendere che l'azione del dialogo era immaginata avvenire prima del 429 a.C., e che probabilmente va collocata nel 432/431 a.C., piuttosto che nel 423/422 a.C.
20) Carmide figlio di Glaucone era zio materno di Platone. Con il cugino Crizia aveva fatto parte dei trenta tiranni ed era morto nella battaglia di Munichia nel 403 a.C., nello scontro fra aristocratici e democratici. è il principale interlocutore nel dialogo omonimo.
21) Santippo era fratello di Paralo e fratello uterino di Callia (cfr. la nota 19).
22) Filippide figlio di Filomelo è un personaggio ignoto da altre fonti. L'unica informazione è questa che ci viene data da Platone, ossia che anch'egli era discepolo di Protagora.
23) Antimero di Mende è un personaggio altrimenti sconosciuto. Ambiva a diventare sofista di mestiere, secondo quanto ci viene detto qui da Platone.
24) Orfeo, mitico poeta della Tracia, figlio, secondo la leggenda, di Apollo e della Musa Calliope, col suo canto ammaliava e trascinava uomini, animali, piante e pietre. Nello Ione (533d seguenti) Socrate chiarisce al rapsodo Ione l'origine divina della forza della poesia: la Musa rende i poeti ispirati, e attraverso questi ispirati si crea una lunga catena di altri che sono invasati dal dio; così i poeti poetano o i rapsodi dicono belle cose intorno ai poeti non per arte o per conoscenza, ma per una forza divina che li possiede e che toglie loro il senno. Con questo parallelo, Platone intende dire che anche l'arte della persuasione di Protagora seduce le anime, e le trascina per effetto di incantesimo, privandole di senno.
25) Omero, Odyssea libro 11, verso 601. La formula «e dopo di lui conobbi» è usata da Omero per legare, nell'evocazione dei morti di Odisseo, l'apparizione di un'ombra all'altra: dopo Sisifo, che appare penare nell'inutile fatica di spingere un masso sulla cima di un colle, e rotolare ogni volta al piano senza poterla raggiungere, Odisseo riconosce l'ombra di Eracle. Platone, usando come nesso fra un personaggio e l'altro questa formula omerica in questa forma (la stessa formula si trova, scomposta, anche in Odyssea libro 11, verso 572), evidentemente vuole stabilire un parallelo fra Protagora e Sisifo e fra Ippia ed Eracle, suggerendo così le caratteristiche che li accomunerebbero: la presunzione di Protagora e di Sisifo (cfr. 348e-349a, sulla fiducia che Protagora ha in se stesso), e la pretesa di onniscienza e di saper fare e parlare di tutto di Ippia di Elide, paragonata alla sconfinata forza di Eracle (su Ippia, cfr. la nota 17).
26) Erissimaco, come il padre Acumeno, fu un celebre medico. Figura come interlocutore nel Simposio (185d), ed è nominato, insieme al padre Acumeno in Phaedrus 268a.
27) Fedro del demo di Mirrinunte è il personaggio protagonista dell'omonimo dialogo. Nel Fedro (227a), egli si dice amico e medico Acumeno, e annuncia di voler andare a passeggiare per le strade all'aperto perché così gli ha consigliato Acumeno. Compare anche nel Simposio (176d seguenti, dove dice di esser solito dare retta, in fatto di medicina. a Erissimaco figlio di Acumeno, e 178a seguenti, dove pronuncia un elogio di Eros.
28) Androne di Androzione è menzionato anche nel Gorgia (487c), come uno dei tre «compagni di sapienza» di Callicle. Prese parte alla rivolta oligarchica del 411 a.C.
29) Cfr. Omero, Odyssea libro 11, verso 583 e seguenti. Il verso omerico è: «e anche Tantalo vidi, che pene atroci pativa»: Tantalo è ritto in piedi in uno stagno, assetato, e non può bere di quell'acqua, che sparisce, inghiottita, appena egli si piega per prenderne; e, sulla sua testa, alberi piegano i loro rami carichi di frutti, ma il vento li alza appena Tantalo si allunga per prenderne.
30) Su Prodico di Ceo, cfr. la nota 18.
31) Pausania del Ceramico è un retore. Nel Simposio (180c seguenti), dopo l'elogio di Eros fatto da Fedro, Platone gli fa esprimere alcune delle idee allora in voga sulla questione d'amore: distinzione fra Eros celeste ed Eros volgare; solo l'Eros celeste è degno dì essere elogiato, eccetera.
32) Agatone fu un poeta tragico, di cui si sono conservati solo pochi frammenti. Nacque intorno al 447 a.C. in casa sua, per festeggiare la vittoria ottenuta con la sua prima tragedia nelle Lenee del 416 a.C., si svolge l'azione del Simposio. In questo dialogo (193b-c) compare un'altra allusione all'amicizia intima fra Agatone e Pausania.
33) Adimanto figlio di Cepide non è noto da altre fonti. Su Adimanto figlio di Leucolofide, sappiamo da Senofonte, Historia Graeca libro 1, 4, 21; libro 2, 1, 30. che fu stratega alla battaglia di Egospotami, e fu processato dagli Ateniesi per tradimento.
34) Su Alcibiade, cfr. la nota 1.
35) Crizia figlio di Callescro, di famiglia aristocratica, era cugino di Perictione, madre di Platone. Divenne capo dei trenta tiranni, e col cugino Carmide, zio di Platone (cfr. la nota 20), morì nella battaglia di Munichia nel 403 a.C.. combattendo contro i democratici insorti. Scrisse opere in versi e in prosa. In Filostrato, Vitae sophistarum libro 1,16, si legge di Crizia che egli parteggiò per gli Spartani, minacciando guerra da parte degli Spartani a chi avesse dato asilo a coloro che egli aveva esiliato da Atene, e collaborando con gli Spartani nel disegno di fare dell'Attica terra da pascolo per le pecore. Il celebre opuscolo antidemocratico "Athenaíon politeia" giunto a noi tra le opere di Senofonte, ma certamente non scritto da lui, potrebbe essere opera di Crizia.
36) Nell'interpretaziOne di Protagora, il "sofista" è colui che sa rendere gli uomini migliori. Omero, dunque, facendo dei suoi eroi esempi di virtù, avrebbe i requisiti per essere definito sofista, nel senso appunto di "colui che educa alla virtù".
37) Nelle Opere e i giorni anche Esiodo dava precetti di vita morale, servendosi dunque, a giudizio di Protagora, della poesia come paravento per mascherare il vero scopo che gli stava a cuore, vale a dire educare alla virtù, e quindi praticare l'arte sofistica nel senso in cui Protagora l'intendeva.
38) Simonide di Ceo nacque intorno alla metà del quinto secolo. Fu poeta corale, di inni, canzoni conviviali (scolia), canti funebri, epitafi, elegie, ma soprattutto di epinici. e trascorse la maggior parte della sua vita alla corte di tiranni: presso Ipparco ad Atene, presso gli Scopadi in Tessaglia, presso gli Alevadi a Larissa e alla corte di Ierone di Siracusa. in Diodoro Siculo, libro 11, 11,4-12,1, ci è conservato un frammento dell'epitafio di Simonide per i caduti spartani alle Termopili. Il tema della virtù, di come essa sia accessibile a pochi, e di come sia impossibile trovare un uomo senza difetto, è ricorrente nella sua opera. Anch'egli, dunque, è "sofista" nel senso che intende Protagora ("maestro di virtù"). Più avanti, su invito di Protagora (339a seguenti), verrà analizzato il suo celebre carme A Scopa.
39) Su Orfeo, cfr. la nota 24.
40) Museo, mitico discepolo di Orfeo, autore, secondo la tradizione, di poemi cosmogonici e di inni sacri.
41) Icco di Taranto fu un famoso atleta, vincitore della gara del pentathlon ad Olimpia nel 470 a.C. Platone lo cita (Leges libro 8, 840a) dicendo che egli, in vista delle gare, per amore della vittoria, sapeva rinunciare ai piaceri del sesso, e che sue erano la virtù della temperanza e del coraggio. Anche la ginnastica contribuiva alla paideia (cfr. Protagoras 312b), l'educazione spirituale del giovane di buone speranze, e dal momento che anch'essa educava alla virtù senza professarlo apertamente, Protagora la considera "arte sofistica" camuffata.
42) Erodico, nativo di Megara, era detto di Selimbria per essersi trasferito a Selimbria. Lasciata l'atletica, fu maestro di ginnastica. è nominato nella Repubblica (libro 3, 406a-b), dove si racconta che, colpito da una malattia mortale, lasciò ogni altro interesse per seguire attimo per attimo il decorso della malattia, senza essere capace di guarirsi, e che così , vivendo solo per curarsi, tirò per le lunghe la sua morte, imprigionato nella sua "dieta", si tormentava se anche di poco deviava da essa, e giunse ad un'età avanzata grazie alla moderna terapia di associare la ginnastica alla medicina. E qui il caso di Erodico è citato in polemica contro il malcostume dei ricchi di curarsi con diete prolungate, prendendosi il lusso di giacere a letto e diventando così un peso per la società, e precisando che ciò non ha nulla ha che fare con l'arte medica di Asclepio.
43) Agatocle fu maestro di musica di Damone (cfr. Laches 180c-d) che a sua volta fu maestro di Pericle (cfr. Alcibiades 118c). il suo discepolo viene citato nella Repubblica (libro 4, 424c), a proposito della necessità di mantenere immutata l'educazione musicale, e di non introdurre nuovi generi musicali, perché questo scuoterebbe i fondamenti su cui poggia la costituzione dello Stato. Nella Repubblica (libro 3, 400b-e), Socrate si richiama all'autorità di Damone per giudicare quali siano i ritmi che traducono la volgarità, la violenza, la pazzia e ogni altro difetto, e quali siano invece i ritmi che traducono le virtù opposte. è dunque chiara la ragione per cui Protagora chiama "sofista" il suo maestro.
44) Pitoclide di Ceo è citato, con Damone, come maestro di musica di Pericle, nell'Alcibiade secondo (118c).
45) Zeusippo di Eraclea è il famoso pittore del quinto secolo a.C., citato con il nome di Zeusi anche nel Gorgia (453c-d), come pittore dì figure vive. Cfr. Aristotele, Poetica 1461b 13.
46) Ortagora di Tebe fu un celebre flautista, maestro di flauto di Epaminonda.
47) Letteralmente "eúbolia" significa 'capacità di consigliarsi bene', 'di prendere giuste decisioni'.
48) Il Consiglio, il più importante organo politico di Atene, era composto di cinquecento membri, cinquanta per ognuna delle dieci tribù. Era presieduto, a turno, dai cinquanta membri di una delle dieci tribù, per un uguale periodo di tempo di 35/36 giorni, secondo un ordine stabilito a sorte. Questi cinquanta membri, per il periodo che presiedevano il Consiglio, si chiamavano Pritani, e Pritania era la carica che essi ricoprivano. Gli arcieri di cui si parla erano guardie al servizio dei Pritani.
49) Si tratta di Paralo e Santippo; cfr. la nota 19. Nell'Alcibiade secondo (118d-e) Socrate chiede ad Alcibiade chi sia stato reso saggio da Pericle, a partire dai suoi due figli. e Alcibiade, cogliendo l'allusione, risponde lasciando intendere che Paralo e Santippo erano considerati due sciocchi.
50) Clinia era fratello minore di Alcibiade, affidato anch'egli, dopo la morte del padre Clinia, alla tutela di Pericle. Nell'Alcibiade secondo (118e), Alcibiade chiama il fratello «pazzo», e fa capire che neppure a costui Pericle seppe trasmettere la propria sapienza.
51) Il nome Arifrone significa 'molto saggio': fu il nome del nonno e del fratello di Pericle.
52) Nel mito Prometeo è un gigante figlio di Giapeto e dell'oceanina Climene. in Esiodo, Theogonia 507 seguenti, è detto versatile e astuto, ingannò Zeus una prima volta, quando, in occasione di una contesa fra il re dell'Olimpo e i mortali, spartì un bue con arte ingannevole, nascondendo le carni e le interiora in una pelle, nel ventre del bue, camuffando le ossa nel grasso, e invitando Zeus a scegliere. Questi, per vendetta, punì Prometeo legandolo ad una colonna e mandando un'aquila a mangiargli il fegato (cfr. il Prometeo eschileo), e tolse ai mortali il fuoco. Prometeo venne liberato da Eracle, e tornò ad ingannare Zeus rubando il fuoco e facendone dono agli uomini. La caratteristica di Prometeo è quella di «contendere contro i disegni di Zeus» (cfr. 5, 534). Nelle Opere e i giorni (versi, 42-57), Esiodo dice che, se Prometeo non avesse violato il divieto di Zeus, rubandogli il fuoco, l'uomo non sarebbe condannato al lavoro e potrebbe senza fatica raccogliere in un solo giorno di che vivere un anno. Il nome Prometeo significa 'colui che pensa prima', il 'previdente'. Il fratello Epimeteo ('colui che pensa dopo', 'l'imprevidente'), già in Theogonia 511-513, è detto «malaccorto», per aver accolto in casa il malefico dono di Zeus, Pandora. Si accorse del malanno che aveva, solo dopo averlo accettato (cfr. Opera et dies 83-89). Il mito costruito da Platone si incentra sul dono del fuoco e della competenza artigiana, sugli effetti che questo dono ebbe, e, soprattutto, sugli effetti che questo dono non ebbe: non bastò a rendere gli uomini capaci di vita associata, e per questo fu necessaria l'arte politica.
53) Ferecrate era un poeta comico ateniese, contemporaneo di Aristofane. La sua commedia I selvaggi, a cui qui si allude, doveva essere la satira della teoria di qualche sofista, allora in voga, che sosteneva la superiorità dello stato di natura rispetto allo stato di diritto. I misantropi di cui si parla, disgustati dalla vita civile, si rifugiarono fra gente selvaggia che fece loro rimpiangere la vita nella società e nelle leggi. La commedia venne rappresentata nel 421/420 a.C., e se si colloca l'azione del Protagora nel 432/31 a.C., bisogna considerare questa citazione un anacronismo. D'altra parte, se si immagina che il dialogo avesse luogo nel 423/422 a.C., risulta anacronistica la presenza dei figli di Pericle, Paralo e Santippo, morti nella peste del 429 a.C. (cfr. la nota 19).
54) Il Leneo era il 'recinto del torchio' presso l'Acropoli di Atene, la piazza dove, nel mese di Leneone (dal 15 gennaio al 15 febbraio), si celebravano le Lenee, feste in onore di Dioniso Leneo ('protettore del torchio'), con rappresentazioni teatrali.
55) Euribate e Frinonda erano due proverbiali malfattori (cfr. Aristofane, Thesmoforiazusae 861).
56) Su Policleto, cfr. la nota 14.
57) Su Paralo e Santippo, cfr. la nota 19.
58) Per questa polemica di Platone verso la scrittura - più precisamente: la scrittura filosofica - e il privilegio da lui riconosciuto allo sviluppo della dialettica orale, cfr. Phaedrus 274b-278e.
59) Crisone di Imera era un famoso atleta, citato, con Icco di Taranto e altri atleti, nelle Leggi (libro 8, 840a-b; cfr. la nota 41), come esempio di temperanza nell'astenersi dai piaceri sessuali per amore di una vittoria. Vinse gare di corsa alle Olimpiadi del 448,444 e 440 a.C.
60) Il dolicodromo è l'atleta che gareggia in una corsa di resistenza, che consisteva nel percorrere dodici diauli, vale a dire dodici volte la doppia lunghezza dello stadio, dal traguardo alla meta e, di ritorno, dalla mèta al traguardo (cfr. Platone, Leges libro 7, 822a; libro 8, 833b).
61) In greco "emerodromos" era un corriere che doveva percorrere in un giorno grandi distanze.
62) Su Alcibiade e il suo atteggiamento verso Socrate, cfr. le note 1-4.
63) Su Crizia, cfr. la nota 35.
64) Su Prodico, e le sue ricerche di sinonimica, cfr. la nota 18.
65) Su Ippia e sulla sua "sapienza", cfr. la nota 17.
66) Il Pritaneo anticamente era la sede dei Pritani (cfr. la nota 48). Si trattava di un edificio pubblico che sorgeva ai piedi dell'Acropoli, dove venivano mantenuti a spese pubbliche i cittadini da cui lo Stato aveva ricevuto particolari benefici, atleti che con le loro vittorie avevano portato lustro alla città, e certi ospiti illustri. In Platone, Apologia Socratis 36d, Socrate sostiene di essere benefattore della città, e di meritare, per questo e per la propria povertà, di essere nutrito a spese pubbliche nel Pritaneo. In questa similitudine messa in bocca ad Ippia, potrebbe esserci, oltre al senso apparente (l'enfatico elogio che Ippia fa della città di Atene e della casa di Callia), il doppio senso comico che fa apparire Atene come il Paese della Cuccagna dei sofisti, e la casa di Callia come l'albergo dove questi "benefattori" alloggiano e pasteggiano a spese del padrone. Del resto, sulla generosità e sul mecenatismo di Callia si è già ironizzato sopra (cfr. 315d), dove si diceva che Callia, per far posto ai sofisti, aveva sgombrato persino la dispensa. Su Callia, cfr. la nota 12.
67) Su Simonide, cfr. la nota 38.
68) Scopa figlio di Creonte era tiranno di Crannone in Tessaglia. Simonide fu accolto alla corte degli Scopadi dopo l'assassinio di Ipparco, suo protettore ad Atene, nel 514 a.C.
69) Si tratta del carme A Scopa, frammento 542. Page.
70) Pittaco di Mitilene visse tra la fine del settimo e l'inizio del sesto secolo. È tradizionalmente annoverato fra i Sette Saggi.
71) Cfr. Omero, Ilias, libro 21, verso 308. Lo Scamandro, adirato con Achille perché massacra i Troiani in fuga nelle sue correnti e le riempie di cadaveri, cerca di travolgere l'eroe con la piena delle sue acque; ma Achille, soccorso da Atena, rimonta la corrente, che non riesce più a trattenerlo. Lo Scamandro allora chiama in aiuto il fratello Simoenta, perché presto Achille espugnerà la rocca di Priamo. Socrate vuole impedire che Protagora=Achille espugni Simonide=roccaforte della sapienza morale.
72) La citazione riprende Esiodo, Opera et dies 289-92, variandone leggermente la sintassi (dal discorso diretto è volta al discorso indiretto e qualche congiunzione è cambiata), sostituendo l'originale «immortali» con «dèi», e saltando parte del verso 290 e parte del verso 291, la frase che diceva: «lungo e ripido è il sentiero che porta ad essa, e aspro all'inizio».
73) Talete di Mileto, nato probabilmente intorno al 640 a.C., "filosofo" fu il primo a cercare nella natura, e non nella mitologia, un "arché", ossia un'"origine" delle cose e un 'principio' che spiegasse il reale, e lo individuò nell'acqua. Su Talete circolavano aneddoti contraddittori, alcuni che lo presentano dedito alla vita contemplativa, come quelto riportato da Platone (Theaetetus 174a), dove si dice che Talete, mentre studiava gli astri e guardava in alto, cadde in un pozzo, e quelli che lo presentano invece come uomo di grande senso pratico, capace di trarre lauti guadagni dal commercio. La tradizione gli attribuisce norme morali espresse in forma di brevi sentenze.
74) Su Pittaco di Mitilene, cfr. la nota 70.
75) Biante di Priene è citato con ammirazione da Eraclito di Efeso nel frammento 39 Diels-Kranz. Diogene Laerzio, libro 1, 82-88, ha raccolto aneddoti sul suo conto e detti memorabili a lui attribuiti.
76) Solone fu "arconte" ad Atene nel 594/593 a.C., e legislatore grazie all'eccezionale potere che gli venne attribuito. Diventato arbitro in seguito a una guerra civile fra nobili e popolo, «liberò il popolo» ordinando la "seisáctheia", cioè lo 'scuotimento dei debiti', e vietando i prestiti su pegno della persona, e stabilì una costituzione, in Aristotele, "Athenaíon politeía" 5-7, sono conservati frammenti di Solone. è celebre la sua elegia Alle Muse, ricca di temi esiodei, quali l'ineluttabilità della vendetta di Zeus, gli inutili affanni degli uomini e le loro vane Speranze.
77) Di Cleobulo di Lindo si conservano aneddoti e detti memorabili in Diogene Laerzio, libri 1, 89-93.
78) Nella lista dei Sette Saggi al posto di Misone di Chene di solito si trova Periandro di Corinto. Di Misone parla Diogene Laerzio, libro 1, 106-108.
79) Chilone di Sparta è anch'egli tradizionalmente annoverato fra i Sette Sapienti. Viene menzionato in Diogene Laerzio, libro 1, 68-73.
80) Cfr. Omero, Ilias, libro 10, verso 224. A parlare così è Diomede, che si offre volontario ad entrare nel campo dei nemici per indagare che cosa i Troiani meditavano fra loro, Il piano degli Achei era quello di informarsi, di cercare di sapere, che è appunto il fine a cui mira la ricerca di Socrate.
81) Cfr. Omero, Ilias, libro 10, verso 225. Il seguito in Omero è:«la mente tuttavia è più corta, il pensiero è più debole».
82) La pelta era uno scudo leggero. Arma tipica dei Traci, fu poi adottata da tutti i Greci.
83) Socrate gioca sul significato del nome Prometeo, che etimologicamente significa 'colui che pensa prima', il 'previdente'. Su Prometeo ed Epimeteo, cfr. la nota 52.







